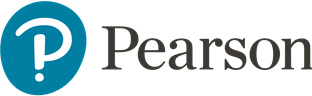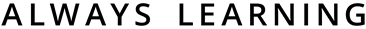Dalla "Grande bellezza" al "Bello dell’italiano": due libri dai destini incrociati

APPROFONDIMENTI DISCIPLINARI - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Il triennio 2011-2014 mi ha visto impegnato nella realizzazione di due libri: un manuale dedicato all’analisi e alla descrizione della lingua e dello stile delle opere dei nostri grandi trecentisti (Dante, Petrarca e Boccaccio) e una grammatica italiana destinata al biennio della scuola secondaria di secondo grado. Il primo libro è nato come impresa solitaria, mentre il secondo è il frutto di un lavoro a sei mani: quelle di Luca Serianni, quelle di Valeria Della Valle e le mie..
I due testi, diversissimi per contenuto, destinazione e finalità, sono curiosamente vicini nel titolo, che è La grande bellezza dell’italiano. Dante, Petrarca, Boccaccio (Patota 2015) nel caso del manuale universitario e Il bello dell’italiano (Serianni, Della Valle, Patota 2015) nel caso del libro di grammatica.
Chi legge stenterà a credere che i due titoli abbiano avuto una genesi distinta e separata, eppure è proprio così: mentre il primo titolo è una mia idea, il secondo è nato da una proposta degli editor della Pearson, che nulla sapevano del primo; una proposta che Della Valle, Serianni e io abbiamo apprezzato ed accolto con piacere.
La combinazione è curiosa, soprattutto se si tiene conto del fatto che l’associazione fra la categoria estetica della bellezza (o, se si preferisce, del bello) e una qualsivoglia lingua è teoricamente inaccettabile: le lingue, in sé, non sono né belle né brutte, quali che siano i criteri assunti per descriverle; sono, e basta. Sul piano storico, però, il collegamento fra la lingua italiana e la bellezza è alla base di una vulgata che ricorre da molto tempo fra le persone colte di tutto il mondo e che, almeno a partire dal XVIII secolo, è diventata «una certezza di massa da “Guide bleu”» (De Mauro 2008: 277). Ne hanno dato e continuano a darne ampia testimonianza gli stranieri, intellettuali e non, che dal Rinascimento in poi hanno di volta in volta qualificato l’italiano come armonioso, delicato, dolce, elegante, fluido, gentile, gradevole, grazioso, liscio, melodico, piacevole, seducente; per non dire del protagonista delle Confessioni del cavaliere d’industria Felix Krull di Thomas Mann, il quale, interrogato da un direttore d’albergo in merito alla sua conoscenza dell’italiano, risponde all’interlocutore in questo modo: «Ma Signore, che cosa mi domanda? Son veramente innamorato di questa bellissima lingua, la più bella del mondo. Ho bisogno soltanto d’aprire la mia bocca e involontariamente diventa il fonte di tutta l’armonia di quest’idioma celeste. Sì, caro signore, per me non c’è dubbio che gli angeli del cielo parlano italiano» (Stammerjohann 2013: 269-270).
«Gli angeli nel cielo parlano italiano», afferma il personaggio di Mann. In effetti, nell’Inferno della Divina Commedia (il primo capolavoro della nostra tradizione linguistica), la parola bellezza non s’incontra mai. I diavoli accolgono in sé tutto il suo contrario. Quello che arriva nella bolgia dei barattieri portando con sé un nuovo dannato è nero e feroce; sulla sua spalla, magra e sporgente, spiccano ali da pipistrello (Inf. XXI 29-36 e XXXIV 49). I suoi compari hanno nomi sgradevoli, da Malebranche (Inf. XXI 37) a Graffiacane (Inf. XXI 122), passando per Scarmiglione e Draghignazzo (Inf. XXI 105 e 121), e comunicano in una lingua che degrada fino al rumore osceno («ed elli avea del cul fatto trombetta», Inf. XXI 139). Lucifero, nel fondo dell’inferno, è qualificato esplicitamente come brutto (Inf. XXXIII 34).
La bellezza comincia a farsi vedere soltanto nel Purgatorio (in cui la parola che la indica ricorre quattro volte), per poi manifestarsi apertamente nel Paradiso (ben sette volte).
Prima che nella Commedia, Dante aveva usato la parola bellezza nella giovanile Vita nova: in sei occasioni, e sempre per riferirsi all’amata Beatrice. Il regno della bellezza, però, non è né nella Vita nova né nella Commedia. È, invece, nel Convivio, in cui il termine ricorre per ben trenta volte (Onder 1970). E in otto dei trenta casi in cui compare, la parola non è associata a un individuo, all’aspetto fisico o spirituale di una donna, né a Dio o alla sua opera, ma a una lingua: segnatamente, a quello che Dante chiama il volgare del sì e che noi, col senno e la terminologia di poi, chiamiamo l’italiano.
Se una lingua non può essere, in sé, né bella né brutta, un dipinto in cui la si evochi non solo può, ma anzi dovrebbe essere bello, per la natura e la destinazione che lo connotano. E bello al punto di essere giudicato uno dei capolavori della ritrattistica italiana è un ritratto di donna di Andrea del Sarto che indirettamente celebra l’italiano, nella fattispecie quello di Francesco Petrarca. Si tratta di un olio su tavola di 87x69 cm. risalente al 1528, conservato presso la Galleria fiorentina degli Uffizi e noto come Dama col Petrarchino. Il quadro ritrae una giovane donna seduta, con le braccia appoggiate ai braccioli di una sedia, la testa lievemente inclinata e rivolta a sinistra, che accenna uno sguardo tenero e ammiccante e un sorriso complice all'osservatore. Il suo vestito, di colore blu genziana, è aperto sul petto, e lascia vedere una camicia bianca lungo la quale corre un laccio che chiude l'apertura. Nel laccio è infilato un piccolo mazzo di fiori. Spiccano le maniche bianche della camicia. La testa è acconciata con eleganza: i capelli sono raccolti in una treccia e decorati da nastri. La donna ha, aperto fra le mani, un “petrarchino”, cioè un esemplare di piccolo formato del Canzoniere di Petrarca (Macola 2007 = 59), aperto su una pagina che contiene due sonetti della raccolta: il 153 e il 154. Il secondo, neanche a farlo apposta, si chiude con un richiamo alla bellezza, direttamente evocata dal francesismo beltà che compare nell’ultimo verso: «or quando mai / fu per somma beltà vil voglia spenta?» (Petrarca 2004: 151, 13-14).
Ma, obietterà ragionevolmente qualcuno, finché si parla di lingua letteraria passi: l’associazione fra l’italiano delle cosiddette “Tre Corone” e la categoria estetica della bellezza è possibile e forse, anche in forza di queste considerazioni, necessaria. Ma che c’entra il bello con la grammatica?
A mio avviso, anzi, a nostro avviso – dico mio e dei coautori – c’entra, perché anche il bello ha la sua grammatica: nella musica come nelle arti figurative, nell’architettura come nel design è indispensabile rispettare tempi, misure e proporzioni; numeri, accostamenti e combinazioni. Lo stesso bisogna fare con la lingua. Le regole grammaticali non sono un’invenzione degli insegnanti, né un’esigenza sorpassata: oggi come ieri, chi parla o scrive in un italiano non corretto viene censurato, prima ancora che dai docenti, dalla comunità dei parlanti.
Il bello, insomma, non esclude la necessità dell’esatto. Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Guglielmo Marconi, Rita Levi Montalcini e molti altri hanno reso l’italiano uno strumento di conoscenza (Nesi, De Martino 2012). La nostra lingua può, anzi deve continuare a comunicare la realtà complessa delle scienze, e riflettere sulle sue strutture aiuta a ragionare. Forti di questa convinzione, nel Bello dell’italiano abbiamo dedicato rubriche e attività alla riflessione sulla lingua (spiccano, nel merito, le domande con l’etichetta Rifletti, disseminate per tutto il testo) e per mezzo della lingua (gli esercizi di logica, anch’essi ampiamente distribuiti nel volume).
Il bello e l’esatto richiedono, a loro volta, padronanza lessicale. Per questo nel libro abbiamo riservato un ampio spazio al lessico, non solo nei capitoli istituzionali (come per esempio quello sulla formazione delle parole) ma anche in rubriche specifiche dedicate alle Etimologie, ai rapporti fra Italiano e latino e a quelli fra Italiano e altre lingue.
Oltre che in questi spazi, la storia dell’italiano è trattata in un capitolo che illustra le ragioni della complessità, della varietà interna, della stratificazione, della straordinaria ricchezza di questa lingua: il bello (o, se si preferisce, la grande bellezza) dell’italiano, appunto, che speriamo di poter condividere con le colleghe, i colleghi, le studentesse e gli studenti.
Riferimenti bibliografici
- De Mauro 2008 = Tullio D. M., Storia linguistica dell’Italia unita, 10a ed., Roma-Bari, Laterza.
- Macola 2007 = Novella M., Sguardi e scritture. Figure con libro nella ritrattistica italiana della prima metà del Cinquecento, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2007.
- Nesi, De Martino 2012 = Annalisa N., Domenico D. M. (a cura di), Lingua italiana e scienze. Atti del convegno internazionale, Firenze, Villa Medicea di Castello, 6-8 febbraio 2003, a cura di Annalisa Nesi e Domenico De Martino, Firenze, Accademia della Crusca.
- Onder 1970 = Lucia O., v. bellezza, in Enciclopedia Dantesca, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1970-78 (6 voll.), vol. I pp. 561-562.
- Patota 2015 = Giuseppe P., La grande bellezza dell’italiano. Dante, Petrarca, Boccaccio, Roma-Bari, Laterza.
- Petrarca 2004 = Francesco P., Canzoniere, edizione commentata a cura di Marco Santagata, nuova edizione aggiornata, Milano, Mondadori.
- Serianni, Della Valle, Patota 2015 = Luca S., Valeria D. V., Giuseppe P., Il bello dell’italiano, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori – Pearson.
- Stammerjohann 2013 = Harro S., La lingua degli angeli, Firenze, Accademia della Crusca.