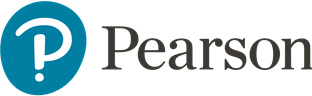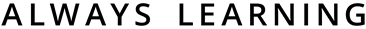Madrelingua e allofoni in classe: che fare?

Per inquadrare il tema
DIDATTICA INCLUSIVA
Il Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri (PLIDA) della Società Dante Alighieri ha messo a punto, tra le sue molte iniziative, anche un programma di formazione specifico rivolto ai docenti. Se un tempo i nostri interlocutori erano soprattutto gli insegnanti di italiano come lingua straniera, negli ultimi anni è diventata sempre più forte la richiesta di formazione da parte degli insegnanti della scuola dell’obbligo, alle prese con classi in cui la percentuale di studenti con lingua madre diversa dall’italiano si è fatta via via più consistente.
Il Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri (PLIDA) della Società Dante Alighieri ha messo a punto, tra le sue molte iniziative, anche un programma di formazione specifico rivolto ai docenti. Se un tempo i nostri interlocutori erano soprattutto gli insegnanti di italiano come lingua straniera, negli ultimi anni è diventata sempre più forte la richiesta di formazione da parte degli insegnanti della scuola dell’obbligo, alle prese con classi in cui la percentuale di studenti con lingua madre diversa dall’italiano si è fatta via via più consistente. Confrontandoci con loro ci siamo resi conto che i problemi comuni possono essere condensati in un paio di affermazioni, che qui cercheremo di illustrare attingendo agli studi sull’argomento; ci limiteremo a offrire alcuni spunti di riflessione: per un approfondimento rimandiamo alla bibliografia essenziale riportata più sotto.
Prima affermazione: «I ragazzi stranieri delle nostre classi sanno comunicare in italiano con gli insegnanti e con gli studenti, ma non sanno studiare in italiano».
Per comprendere questo fenomeno bisogna tener conto di almeno tre aspetti:
- Le competenze linguistiche necessarie all’interazione quotidiana sono diverse da quelle grazie alle quali studiamo. Nel 1979 Jim Cummins diede alle prime il nome di BICS (Basic Interpersonal Communicative Skills) e alle seconde quello di CALP (Cognitive Academic Language Proficiency). Un apprendente che sa usare l’italiano in contesti legati alla sopravvivenza quotidiana non è necessariamente in grado di servirsene anche nello studio; è verosimile invece che per ottenere dei risultati abbia bisogno di ricevere strumenti adatti alle sue competenze CALP. In altre parole: proporre a un apprendente che non ha ancora raggiunto competenze di tipo CALP di leggere un capitolo di storia, di svolgere un tema o di prendere appunti durante una lezione è inutile.
- Quando parliamo di “strumenti adatti” ci riferiamo a testi semplificati, attività specifiche e tutto ciò che permetterà all’apprendente straniero di raggiungere i propri obiettivi in tempi adeguati. Questi elementi lo porteranno a sviluppare le proprie capacità accademiche secondo il principio sintetizzabile con la formula "i più 1"(Krashen 1985): se per "i" si intendono le capacità del discente, il "più 1" rappresenterà la sfida che stimola l’apprendimento.
- Se le attività sono troppo difficili (o troppo facili), lo studente si sente frustrato, inadatto allo studio, inadeguato: viene a mancare la sua motivazione. Di conseguenza, l’apprendente non impara, e questo blocco riguarderà probabilmente tutte le materie scolastiche.
Gli insegnanti di italiano, quindi, hanno una grande responsabilità: da un lato, devono dare a ciascuno studente obiettivi linguistici adeguati; dall’altro, devono mantenere alta la motivazione dei singoli e della classe. Per fortuna in quest’avventura non sono soli. L’italiano, infatti, è la lingua usata in tutte le discipline di studio: portare i discenti a saper studiare in italiano, quindi, dev’essere un obiettivo condiviso da tutto il corpo docente. Ogni collega (a cominciare da quelli di lingua straniera) sarà quindi parte attiva di questo processo.
Seconda affermazione: «I ragazzi stranieri rallentano l’attività dell’intera classe. È difficile gestire venti/trenta alunni con bisogni molto diversi tra loro».
Questa frase contiene una verità: gestire le classi multilivello è difficile. Anzi, difficilissimo. In una classe di questo tipo il ruolo del docente facilitatore e regista dell’apprendimento è più che mai rilevante: l’insegnante individua i bisogni degli studenti, li traduce in obiettivi adeguati, usa approcci e metodi che gli permettano di coinvolgere tutti (cooperative learning, peer tutoring), ricerca e costruisce gli strumenti didattici appropriati (input visivi, audio, testi, esercizi, testi semplificati, ecc.), verifica i progressi di ciascuno.
Dalla teoria alla pratica
Un buon modello operativo per affrontare queste difficoltà è rappresentato dall’Unità Stratificata e Differenziata (USD). Tramite l’USD è possibile proporre «attività, compiti, esercizi organizzati a strati, che vanno dal più semplice al più complesso ma che possono essere utilizzati simultaneamente in classe […]». (D’Annunzio e Della Puppa in Caon 2006, pp. 147-148). Ne riportiamo qui sotto un esempio.
Scheda di progettazione per la costruzione di una Unità Stratificata e Differenziata (USD)
INFORMAZIONI GENERALI
Destinatari: studenti di una classe del primo biennio della scuola secondaria di secondo grado. Classe plurilingue composta da 24 studenti, di cui 4 non italofoni: un rumeno e un turco di livello B1 (secondo la scala del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, in cui A1 è il primo di sei livelli, fino a C2), un filippino e un cinese di livello A2.
Docenti e discipline coinvolte: italiano, storia e informatica. Alcuni contenuti sono stati trattati in precedenza con il docente di geografia.
Tempo: il modulo ha una durata di 20 ore. Le ore del percorso interdisciplinare sono 10.
Titolo della USD: Visti dagli altri.
Gli studenti di questa classe stanno affrontando in storia l’età tardoantica dell’impero romano. Hanno già affrontato il tema in diverse lezioni e si è posta una particolare attenzione sugli usi e i costumi dei romani e delle popolazioni barbare. In classe, a gruppi, si sono già svolte brevi ricerche sull’argomento.
Obiettivi generali:
- favorire l'interdipendenza positiva tra gli studenti;
- favorire la conoscenza dei contenuti disciplinari degli argomenti trattati;
- favorire il dialogo e l'interazione attraverso il lavoro di gruppo;
- esplorare, riconoscere e saper produrre testi sugli argomenti proposti;
- sviluppare le abilità orali e le competenze testuali;
- favorire il decentramento culturale;
- produrre testi in cui si evidenzino le differenze culturali tra romani e popoli barbari.
Stratificazione degli obiettivi linguistico-comunicativi sui due livelli:
Livello A2: saper individuare e utilizzare la frase negativa e affermativa; saper comprendere alcuni vocaboli legati alla disciplina di storia (si utilizza come base un testo semplificato appositamente preparato: della semplificazione dei testi parleremo in un contributo sul prossimo numero di “Folio.net”); saper rispondere e porre brevi domande; utilizzare le frasi positive e negative (per esempio: I barbari sono…, ma non sono…) producendo un testo scritto in cui si descrivono gli usi e costumi dei romani e dei barbari.
Livello B1: saper individuare l’imperfetto; ampliare il lessico; saper rispondere e porre brevi domande; utilizzare l’imperfetto per un breve testo scritto in cui si descrivono gli usi e costumi dei romani e dei barbari.
Video utilizzato come input: Balla coi lupi (minuti 1,11 - 3,26).
Che cos’è PLIDA
Il PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) è un insieme di opportunità a disposizione di chi apprende, insegna, promuove l'italiano: certificazione di italiano come lingua straniera, aggiornamento degli insegnanti, risorse e progetti didattici, assistenza linguistica a migranti e cittadini immigrati, materiali didattici.
Per approfondire
- Balboni P.E., Le sfide di Babele. Insegnare le lingue nelle società complesse, Utet, Torino 2002.
- Bettoni C., Imparare un’altra lingua. Lezioni di linguistica applicata, Laterza, Roma-Bari 2001.
- Bertocchi D., Quartapelle F. (a cura di), Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione, (ed. it. del Common European Framework of Reference for Languages del Consiglio d’Europa), La Nuova Italia, Firenze 2002.
- Caon F. (a cura di), Insegnare italiano nelle classi ad abilità differenziate, Guerra, Perugia 2006.
- Caon F., Educazione linguistica e differenziazione: gestire eccellenze e difficoltà, Utet, Torino, 2008.
- Diadori P., Insegnare italiano a stranieri (nuova edizione), Le Monnier, Firenze 2011.
- Giacalone Ramat A., Verso l’italiano, Carocci, Roma 2003.
- Kagan S, L’apprendimento cooperativo: l’approccio strutturale, Edizioni Lavoro, Roma 2000.
- Krashen S., Second Language Acquisition and Second Language Learning, Pergamon, Oxford 1981.
- Krashen S., Principles and Practice in Second Language Acquisition, Pergamon, Oxford 1983.
- Pugliese R., Capasso R., Bindi D (a cura di), Parlo italiano. Insegnare e apprendere l’italiano L2 nella scuola dell’obbligo, Centro di documentazione della città di Arezzo, Arezzo 2001.