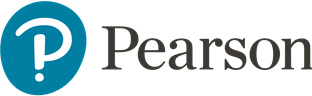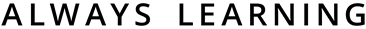Coerenza testuale e coerenza intertestuale
IDEE PER INSEGNARE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La coerenza, insieme alla completezza del messaggio, è un requisito essenziale del testo. Possiamo verificare la coerenza di un testo analizzando la successione e l'intreccio di argomenti e informazioni e considerando la relazione tra il testo stesso e l'extratesto.
Per quanto concerne il primo aspetto preso in esame, la disposizione di argomenti e informazioni, si può ricorrere alle definizioni di dato e nuovo. Per dato si intende quanto nel testo viene presentato come già noto ai destinatari, mentre il nuovo è quanto non è ancora presente nel discorso. Insomma, senza il nuovo un testo sarebbe inutile, almeno dal punto di vista informativo.
Un esempio: un tema di terza classe della scuola secondaria di primo grado
Proviamo ad applicare queste categorie al tema di una studentessa del terzo anno della scuola secondaria di primo grado per analizzare la coerenza del testo. Abbiamo inserito tra parentesi quadre le definizioni di dato e nuovo.
«La nonviolenza è la legge degli uomini, la violenza è la legge dei bruti. Noi non possiamo vincere il nostro avversario che con l'amore, non con l'odio». Rifletti su questa affermazione di Gandhi ed esprimi le tue idee in proposito.
La frase del Mahatma Gandhi [dato] proposta dal tema [dato] è rappresentata da un'altra sua bella frase [nuovo] nella quale [dato ex nuovo] m'identifico molto [nuovo] e che [dato ex nuovo] recita: «Ci sono cose per cui sono disposto a morire, ma non ce ne è nessuna per cui sarei disposto ad uccidere» [nuovo]. In altre parole, non c'è alcun ideale, o valore, o principio che giustifichi una guerra o un omicidio; ma il sacrificio della propria vita, sì. Questa filosofia [dato ex nuovo] discende dall'Illuminismo [nuovo], che [dato ex nuovo], essendo nato in Francia, ci è molto vicino dal punto di vista culturale [nuovo]. Fu infatti Voltaire [nuovo] ad affermare che «Io combatto la tua idea, che è diversa dalla mia, ma sono pronto a battermi fino al prezzo della mia vita perché tu, la tua idea, possa esprimerla liberamente» [nuovo].
Penso che il messaggio che ci hanno lasciato sia Gandhi che Voltaire prima di lui [dato ex nuovo], sia ancora molto attuale [nuovo]. Nel mondo di oggi [dato ex nuovo] ci sono ancora troppe guerre e violenze come modo per mettere fine ai conflitti [nuovo]. Gandhi [dato ex nuovo] ci dice che alla violenza non ci si oppone con altra violenza ma con l'ascolto, la comprensione dell'altro e, appunto, la nonviolenza [dato ex nuovo]. Credo che questo [dato ex nuovo] sia un “metodo” giusto, lungimirante, l'unico che possa portare ad una pace duratura [nuovo], a differenza delle guerre che comportano la vendetta, i vinti da una parte, i perdenti da un'altra [nuovo]. Mi rendo conto che a volte è più facile ricorrere alla guerra o usare le armi [nuovo], ma bisogna avere la determinazione e la costanza del dialogo e della nonviolenza per ottenere frutti migliori [nuovo].
Parlare di violenza [dato ex nuovo] comprende non solo atti di forza tra diverse popolazioni o paesi, ma anche la violenza contro singoli individui [nuovo], in particolare mi riferisco alle donne [nuovo]. In molti paesi la donna [dato ex nuovo] viene ancora considerata inferiore o non gode degli stessi diritti degli uomini [nuovo]: anche questa è una forma di violenza [dato ex nuovo]. Ciò [dato ex nuovo] è un tema che mi preoccupa molto e di cui vorrei in futuro occuparmi [nuovo].
Un altro grande uomo, Aldo Capitini, conosciuto come il Gandhi italiano [nuovo], disse «Con la non violenza riconosciamo il diritto di tutti all'esistenza, con la non menzogna il diritto di tutti alla verità» [nuovo]. Mi piace [nuovo] questa frase [dato ex nuovo] perché il suo contrario è che con la violenza condanniamo tutti alla morte, e con la menzogna tutti alla mancanza di verità [nuovo]. Mi riconosco molto [nuovo] in questi concetti [dato ex nuovo] e vorrei tanto che fosse così per il mondo intero [nuovo].
Qualche osservazione sulla coerenza interna
In genere, come si vede anche in questo tema, il discorso procede dall'informazione con il minor grado di novità a quella con una dose maggiore di novità.
Possiamo notare che alla fine del primo paragrafo, dove c'è una successione di tre elementi nuovi, una frase («ci è molto vicino dal punto di vista culturale») rappresenta l'anello debole della catena logica. Nel secondo paragrafo, è un'altra sequenza di elementi discorsivi identici, questa volta di tre elementi dati, laddove si riporta il pensiero di Gandhi, a rivelare che c'è un passaggio a vuoto («questo»). Seguono quattro elementi nuovi, in cui si concentra l'opinione della scrivente. Alla fine del terzo paragrafo ancora un dimostrativo superfluo («ciò»), su cui ci mette in guardia la successione di due dati. La rottura dell'alternanza tra dato e nuovo pone un dubbio rispetto alla coerenza all'inizio del quarto e ultimo paragrafo, con il riferimento, un po' brusco, a Capitini. Apprezzabile, nel finale, il doppio rovesciamento dell'ordine abituale di dato e nuovo per mettere in evidenza l'opinione dell'autore del testo.
L'osservazione delle serie di dato e nuovo fornisce dunque elementi utili per verificare la coerenza interna del testo.
Il rapporto tra il testo e l’extratesto
Sull'altro aspetto che abbiamo preso in considerazione, cioè i rapporti tra il testo e l'extratesto, la casistica è molto ampia. In ambito didattico potrebbe rivelarsi efficace prendere spunto dagli scritti degli studenti per riflettere sulle implicazioni testuali a partire dalle citazioni.
Qual è la soglia dell'implicito, superata la quale, tutto va chiarito ed esplicitato? L’esperienza didattica rivela che i fraintendimenti sono frequenti, anche quando l'enciclopedia comune è sotto gli occhi del mittente e del destinatario della comunicazione linguistica.
Prendiamo a esempio i compiti di analisi di un testo non letterario svolti da una classe quarta di liceo classico. Osservando l’uso delle citazioni presenti (che sono peraltro fondamentali anche nelle tipologie dell'articolo di giornale e del saggio breve, le più sperimentate all'esame di Stato), possiamo ricavarne un saggio degli equivoci a cui si accennava.
- Diamo per scontato che l'analisi testuale prodotta dallo studente dovrà essere un testo autosufficiente, del tutto autonomo. Eppure, nonostante le esortazioni a confezionare un testo autonomo, si può trovare all'inizio:
(1) «In questo articolo [...]»,
senza altra indicazione utile all'identificazione dell’articolo a cui si fa riferimento.
- Non mettere le citazioni tra virgolette e modificare il testo originale tra virgolette, senza alcun segnale di avviso del mutamento, sono spie della mancanza di confini tra testo ed extratesto. Per esempio in (2) le virgolette sono usate anche se la citazione non è alla lettera:
(2) «Bisogna, però, “farsi sorprendere dalla realtà”».
- Capita che siano i tagli di citazione a essere segnalati senza alcuna giustificazione né utilità:
(3) «si ricollega alla tesi principale che chiude il testo (rr. 101-2): “[...] questo Paese può ripartire solo dai diritti. È dai diritti che nasce una nuova possibilità per tutti”».
(4) «spesso l'autore si serve delle negazioni (es.: “come non dar ragione […]”, “non meno importante”, “no, non tutti i giovani [...]”».
(5) «dall'inizio fino a “[...] di costruire una famiglia […]”».
- Un caso di citazione abbreviata, con danno alla comprensione, è il seguente:
(6) «Enfatizza inoltre il concetto che “migliaia” non sono tutti ma sono comunque una quantità significativa con la ripetizione di “non vuol dire […] significa”».
Poiché la ripetizione si coglie solo riportando fedelmente l'originale:
«“migliaia” non vuol dire maggioranza, non vuol dire […] ma “migliaia” significa [...]».
- E si arriva all'omissione della citazione:
(7) «[il giornalista] utilizza due frasi brevi per esprimere l'idea che senza fatti è impossibile una ripresa».
Le due frasi però non sono trascritte e mancano riferimenti che consentano di recuperarle.
- A volte la citazione risulta del tutto inspiegabile:
(8) «Ragazzi che a migliaia fanno da ore la fila (per descriverla l'autore utilizza la metafora dell'anaconda) per una tessera dell'“abbonamento ai musei cittadini a tariffa speciale”».
- Nello stesso testo si può trovare questa approssimazione:
(9) «Nel primo blocco l'autore descrive lo stereotipo del ragazzo dai quindici ai venticinque anni, facendo riferimento all'articolo di Ernesto Galli della Loggia».
Quale sia questo articolo non è detto.
- Fino a questo punto abbiamo segnalato un ricorso maldestro alle citazioni, che ha a che fare con il contenuto del testo. Nell'esempio che segue la mancanza di confini coinvolge addirittura il piano sintattico:
(10) «Rivolge quasi un appello “è giunto il tempo”, che cadrà nel vuoto».
In conclusione, attraverso le citazioni si richiama la necessaria attenzione sul ricorso all'implicito e al presupposto, con cui si gioca la partita della compiutezza del testo.