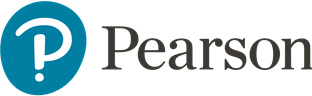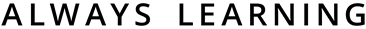Anno nuovo, mali vecchi: scrittura e lettura a scuola

IDEE PER INSEGNARE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
La scuola italiana soffre di mali storici e universalmente riconosciuti: inadeguatezza delle strutture, endemica penuria delle risorse finanziarie, burocrazia farraginosa, carenze nella formazione e nella selezione del personale, precarietà degli organici... Ma ve ne sono altri, radicati, subdoli e pressoché inattingibili, dei quali ci si occupa e ci si preoccupa di meno, ma che non sono meno gravi… Si pensi soltanto alla scrittura e alla lettura.
Perché a scuola si scrive?
È ovvio: per imparare a scrivere e per dimostrare che si è capaci di farlo.
Si scrive per forza, e non per amore, per compiacere l’insegnante, e non per piacere, per ottenere la sufficienza, per primeggiare, per non essere rimproverati o umiliati, per non dispiacere i genitori, per essere promossi… Si scrive addirittura per punizione.
La scrittura come esercizio puro, spiegava Lev Semënovič Vygotskij quasi un secolo fa, «necessita di moltissima attenzione e sforzo da parte dell’insegnante e dell’allievo e diviene perciò qualcosa di chiuso in sé stesso, relega sullo sfondo la lingua scritta viva. Invece di esser fondata sui bisogni dei bambini così come si sviluppano naturalmente e sulla loro attività, la scrittura è data dal di fuori, dalle mani dell’insegnante».
A scuola si scrivono soprattutto temi
Pratica diffusissima, prevalente anche nelle prove d’esame, così come in molti concorsi, ma non per questo meno irrazionale; un’inveterata abitudine (pseudo)didattica che non ha fondamento pedagogico alcuno, per la quale non è possibile rivendicare nemmeno una qualche legittimazione di natura istituzionale.
Sorprende la longevità di questa peculiare forma di scrittura. Il tema è il testo scolastico per antonomasia; nessuno sfugge a questa prova: le fortune e le disgrazie (non solo scolastiche) di moltissimi studenti sono affidate innanzitutto alla capacità di svolgere correttamente un tema. È vero che con l’introduzione del nuovo esame di stato, le tipologie praticate alle scuole secondarie di secondo grado si sono ampliate e diversificate (analisi guidata, saggio breve e articolo di giornale), ma il tema di storia e il famigerato tema di ordine generale sono saldamente rimasti al loro posto.
Si pensi invece allo scarso impiego delle tecniche ideate e sperimentate da Célestin Freinet: il testo collettivo, la corrispondenza o il giornale; luoghi (laboratori) di costruzione, di affinamento e di socializzazione delle capacità espressive e comunicative degli apprendisti scrittori. Testi strutturalmente diversi, che sollecitano abilità cognitive e metacognitive destinate, altrimenti, a sclerotizzarsi, accomunati dal riferimento a uno sfondo, a un ambiente di apprendimento significativo per l’alunno, impegnato non in compiti sterili e imponderabili, ma nella realizzazione di progetti che nascono da esigenze, bisogni e (finanche) desideri autenticamente condivisi. La lingua si realizza nei suoi diversi usi e nei suoi diversi scopi; e ogni scopo determina la forma del testo – non più lo scrivere in astratto, il tema generico, senza alcun senso, oltre quello di produrre comunque qualche paginetta di scrittura.
In questo modo gli studenti imparano a riconoscere e ad affermare le loro esigenze fondamentali non solo a livello di vissuto personale, ma anche in una dimensione che si allarga al gruppo, alla classe. Crescono nuove sensibilità verso gli altri, verso le cose, verso l’ambiente; maturano disponibilità sociali, bisogni e sicurezza nell’operare insieme, nel comunicare, nell’ascoltare, nel criticare per crescere. Sorge in tal modo la percezione dell’essere comunità.
Il tema è invece un’attività autoreferenziale perché la comunicazione è scarnificata, non ha ragion d’essere, si risolve in sé stessa. Funziona solo nella e per la scuola.
Viceversa l’educazione linguistica – ci ricorda Tullio De Mauro - non si fa solo lavorando in astratto su parole, forme, tipi di testo, ma comporta il commercio, l’esperienza del commercio con gli altri esseri umani.
E la lettura? Perché a scuola si legge?
È ovvio: per imparare a leggere e per dimostrare che si è capaci di farlo.
Con esiti disastrosi: più della metà degli italiani non legge e siamo stabilmente relegati in fondo alle classifiche internazionali. Lo confermano con penosa regolarità le ricerche (Istat, Censis, Ocse…) sui comportamenti di lettura di una popolazione che pure vanta un alto tasso di scolarità.
A scuola si studiano raccolte, frammenti, rassegne di scritti, non sempre riportati integralmente, proposti a scopo dimostrativo e accompagnati da istruzioni per l’uso didattico, agevolato da esercizi più o meno artificiosi.
L’uso dei testi è perciò strumentale rispetto alla, peraltro, legittima esigenza di sviluppare e perfezionare abilità tecniche di lettura e capacità di analisi e comprensione.
Purtroppo in questo modo si tradisce l’autentica vocazione dell’opera originale (e integrale). I libri si scrivono perché gli altri li leggano e ne ricevano informazioni, suggestioni, conforto e insegnamento, e non perché siano sezionati con accanimento in ambienti emotivamente sterili.
Chissà quanti, tra gli scrittori più insigni e celebrati, avrebbero continuato la loro opera se ne avessero sospettato un uso prettamente scolastico; se avessero immaginato il tedio, gli affanni, le sofferenze che avrebbe procurato a milioni di individui lo studio dei loro testi, concepiti, invece, per deliziare, stupire, commuovere, indignare, scandalizzare (insomma tutto fuorché affliggere o annoiare); se avessero intuito i timori, le angosce, ma anche la rabbia e l’odio che interrogazioni e verifiche avrebbero indissolubilmente coniugato alla lettura dei loro versi più ispirati; se avessero previsto che i loro libri da strumenti di elevazione e arricchimento si sarebbero trasformati in strumenti di tortura e avvilimento.
Non possiamo fingere di non sapere che il libro più studiato nelle scuole, I promessi sposi, è senza dubbio “il più odiato dagli italiani”, e probabilmente il meno letto, per intero s’intende, fatta cioè eccezione per le parti delle quali è stata imposta l’analisi letteraria. Così «il libro diventa un oggetto contundente, un blocco di eternità, la materializzazione della noia», ammonisce Daniel Pennac.
Quando chiesero a Umberto Eco di definire la nozione di classico, in senso letterario, la risposta fu: «Nulla di più facile che definire un classico: è un libro che tutti odiano perché sono stati costretti a leggerlo a scuola».
Privare i contemporanei del conforto dei classici significa rinunciare non a qualcosa di importante che rimanda al passato, ma a qualcosa di fondamentale, che resiste al presente, in opposizione dialettica alla contingenza, al modus, cioè al moderno e alla moda. Portare con sé i classici, averli in sé, farli propri significa dotarsi di potentissime difese contro il rischio, sempre più incombente dell’omologazione e della miseria esistenziale, significa sottrarsi alla reazione prevedibile e immediata di chi sia succube dell’impressione momentanea, disarmato di fronte al presente, confuso nell’attualità, fino a diventarne schiavo; di chi non sappia distanziarsi criticamente, assumere un punto di vista altro, aprirsi a una diversa o più ampia prospettiva. Leggere i classici non è un modo di gettare "i morti in faccia ai vivi", per dirla con Leopardi, significa invece contraddire la tirannia del momento, elevarsi oltre la consuetudine più prosaica.
Rousseau ebbe a definire la lettura «il flagello dell’infanzia», aggiungendo: «un fanciullo non è granché desideroso di perfezionare lo strumento con il quale lo si tortura: ma fate che questo strumento serva ai suoi piaceri, e ben presto egli vi si applicherà vostro malgrado».
Invece a scuola il piacere della lettura è presupposto, pretesto, ma risulta, di fatto, coartato nel momento stesso in cui si tenta di inculcarlo mediante un’esposizione (forzata) che presenta caratteri di omogeneità, artificiosità emotiva - si pensi alla canonica prescrizione: leggere da pagina... a pagina...
Il verbo leggere non sopporta l'imperativo
A nulla valgono intimazioni o intimidazioni: «il verbo leggere - spiega Pennac - non sopporta l’imperativo, avversione che condivide con alcuni altri verbi: il verbo amare... il verbo sognare...».
La prescrizione, la costrizione, così come l’esortazione assillante non solo appaiono inutili, ma risultano addirittura controproducenti, trasformano la lettura in un supplizio da interrompere non appena possibile.
Così gli studenti vivono la lettura non come una possibilità di sviluppo e crescita del loro essere, o più semplicemente come una appassionante avventura, ma solo come un compito fastidioso, opprimente.
È «come se […] il ruolo della scuola si limitasse sempre e dovunque all’apprendimento di tecniche, all’imperativo del commento e con la proscrizione del piacere di leggere impedisse l’accesso immediato ai libri. Sembra assodato, da sempre, sotto ogni latitudine, che il piacere non debba figurare nei programmi scolastici e che la conoscenza possa essere solamente il frutto di una sofferenza ben capita» – il monito è di Pennac.
Fatta salva la necessità di insegnare agli studenti a comprendere e analizzare i testi che leggono, ai docenti spetta dunque il compito fondamentale di restituire la lettura alla sua originaria dimensione: anziché esigerla e imporla, possono condividerla, promuoverne e favorirne il piacere anche fine a sé stesso, e non sempre comunque finalizzato a performance e valutazioni strettamente scolastiche.
Un compito, è ancora Pennac a illuminarci, che si afferma pienamente nel momento in cui si risolve la sua necessità, quando «la voce del professore diventa un’interferenza: piacere parassita di una gioia più sottile»; perché «il vero piacere del romanzo è tutto nella scoperta di questa intimità paradossale: l’autore e io… La solitudine della scrittura che invoca la resurrezione del testo attraverso la mia voce muta e solitaria. In tutto questo il professore è soltanto una mezzana ed è giunto il momento che se ne vada in punta di piedi».