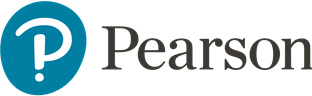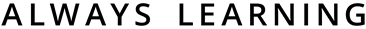Il tema d'esame alla scuola media

Dare senso a una prova che prova poco… ma almeno ci prova
IDEE PER INSEGNARE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
L'insegnamento della scrittura non può ridursi soltanto alla trasmissione di regole su sintassi, lessico e ortografia: la sfida è far sì che per i ragazzi la scrittura diventi autentica, reale, un'occasione per esprimere qualcosa di sé. In tal senso, anche le tracce per l'esame di stato dovrebbero tradursi in richieste non generiche, ma ben focalizzate su attività o esperienze scolastiche significative.
Insegnare a scrivere: solo trasmissione di regole?
Quello dell'insegnamento della scrittura rimane senza dubbio uno degli snodi più problematici nella quotidiana pratica didattica. È importante interrogarsi sui motivi, e lo è soprattutto nel momento in cui si vuole riflettere sul tema d'esame, verifica finale del lungo percorso di apprendistato alla scrittura che gli studenti compiono durante il primo ciclo di istruzione, dalla prima elementare alla terza media.
Chiunque abbia anche solo una limitata esperienza di insegnamento nel primo ciclo, e più precisamente nella scuola secondaria di primo grado di cui si sta parlando qui, sa benissimo quanto sia complessa la questione e come sia difficile trovare una didattica dello scrivere efficace. Certamente bisogna fare in modo che a scuola vengano trasmesse quelle competenze tecniche che riguardano sostanzialmente la sintassi, il lessico e l'ortografia (si pensi alla recente Lettera dei seicento con la quale docenti universitari e intellettuali hanno denunciato le scarse competenze linguistiche degli studenti italiani).
Ma l'insegnamento della scrittura non può ridursi solo a questo: la maggiore problematicità infatti non risiede nella difficoltà a trasmettere una serie di regole o ad applicare pratiche come il dettato o il riassunto o l'analisi grammaticale.
A scuola la scrittura non è un processo comunicativo autentico
A scuola insegnare a scrivere è difficile soprattutto perché si fa fatica a trasmettere ai ragazzi il senso profondo di questa attività, e questo accade perché la scrittura in ambito scolastico è il più delle volte deprivata del suo fine principale, che è quello di comunicare o esprimere qualcosa a qualcuno. Quel flusso vivo tra emittente, messaggio e destinatario, che è in grado di innescare un processo comunicativo autentico, a scuola semplicemente non c'è. Il primo elemento che viene a mancare è proprio quello determinante: il destinatario. Per chi scrivono i ragazzi, quando scrivono a scuola? Di norma, solo per l'insegnante, che però non è visto come un lettore, bensì come un soggetto giudicante, il cui ruolo nel processo comunicativo non è tanto quello di accogliere e comprendere il messaggio inviato, quanto quello di valutarlo. Di tutte le forme di scrittura prodotte nella prassi didattica, il tema è forse quella che meglio rappresenta questa carenza, questa discrasia tra l'intima essenza dello scrivere e il modo in cui lo scrivere entra nelle aule scolastiche.
La sfida affrontata ogni giorno da insegnanti appassionati e consapevoli è invece quella di riavvicinare la scrittura al patrimonio esistenziale dei bambini o ragazzi; di trasportarla dal piano dell'esercizio a quello dell'esperienza, attraverso pratiche di scrittura che riattivino il flusso vitale tra emittente, messaggio e destinatario. Per questo fine tanti insegnanti cercano di sperimentare molteplici forme di scrittura, anche non strettamente "accademiche", messe in atto con metodologie che mirano a restituire vita e concretezza a un'attività spesso mummificata da un approccio troppo tassonomico. Possiamo qui solo accennare brevemente ai testi collettivi, alle esercitazioni di scrittura creativa, o all'ormai imprescindibile riferimento alle nuove forme di comunicazione del web, dai blog alle chat, che per molti ragazzi costituiscono il primo, e a volte il solo contatto con il mondo della scrittura. Contatto discutibile fin che si vuole, ma indubbiamente reale e autentico, per loro.
Il punto, insomma, è sforzarsi di far capire ai ragazzi che si scrive per dire qualcosa, che la prima ragione di essere della scrittura e il suo senso reale risiedono nel fatto di poter trasmettere ad altri qualcosa di sé.
Certo, anche il tema può funzionare, in alcuni casi: quando un alunno è riuscito a sviluppare un rapporto sereno e proficuo con la scrittura, quando ha già imparato a riconoscervi un mezzo di espressione a sé congeniale, quando si trova a proprio agio con la sintassi e con le diverse tipologie di testi che un tema può accogliere…: tutte condizioni che riguardano solo un'esigua minoranza del popolo di studenti che ogni anno affronta l'esame di fine ciclo. Eppure, proprio il tema permane come unica tipologia di prova per la valutazione delle competenze linguistiche scritte.
Una seria e sincera riflessione sullo scritto di italiano all'esame di stato non può prescindere dalla consapevolezza di quanto questa prova sia limitata e limitante, rispetto ai percorsi di apprendimento e di addestramento alla scrittura che vengono o dovrebbero venire proposti nel corso dei tre anni di scuola secondaria di primo grado.
La gabbia nella gabbia: le Indicazioni ministeriali
Il tema diventa una prova ancora più limitante e inadeguata quando si prendono in considerazione le indicazioni che il Ministero ha fornito in merito all'esame scritto di italiano. A questo proposito, a tutt'oggi le circolari ministeriali fanno ancora riferimento al D.M. del 26 agosto 1981, il quale, riguardo all'elaborazione delle tracce per la prova scritta, fornisce una gamma ben definita di tipologie e tematiche che, per quanto definite "indicazioni di massima", di fatto limitano in modo determinante la libertà di movimento dei docenti. La terna di temi da proporre ai candidati dovrà infatti comprendere:
" - esposizione in cui l'alunno possa esprimere esperienze reali o costruzioni di fantasia (sotto forma di cronaca o diario o lettera o racconto ecc.);
- trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l'esposizione di riflessioni personali;
- relazione su un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina."
Davvero si fatica a comprendere come indicazioni così specifiche e restrittive riescano a convivere con il cappello introduttivo che le precede, nel quale si afferma che la prova scritta di italiano "traendo motivo di innovazione dal nuovo programma e, in particolare, dalla vasta gamma di indicazioni in esso contenute circa le esercitazioni scritte degli alunni nell'arco del triennio, si propone di offrire al candidato la possibilità di utilizzare la ricchezza e la varietà di tali sollecitazioni", con il proposito di "rispondere quanto più è possibile agli interessi degli alunni".
Di fatto, la facoltà di scelta dei docenti può spaziare tra tre sole tipologie di tema ben precise, implicitamente rivolte ad altrettanti distinti livelli di competenza raggiunti dai candidati: il tema "argomentativo", pensato per gli alunni "di fascia alta"; la relazione, concepito invece come possibilità abbordabile anche da parte degli alunni con difficoltà a scrivere; e infine, il cosiddetto "tema personale", a farla un po' da jolly.
Il pensiero sotteso a questa strutturazione della prova scritta è discutibile sotto diversi aspetti: il più grave è che quelle "ricchezza e varietà", che ne dovrebbero essere i principi ispiratori, non si coniugano come varietà di contenuti, di proposte e di approcci metodologici, ma si limitano invece a una assai più mortificante varietà di livelli. Per farla semplice: la traccia più impegnativa e articolata "per quelli in grado", la relazione … per gli altri. Dove emerge subito un'ulteriore pecca di questa proposta: siamo proprio sicuri che sia così semplice stendere una buona relazione? Ai nostri ragazzi più fragili, stiamo davvero proponendo la forma di scrittura più semplice, la più immediata, quella che possono sentire più vicina a sé, più congeniale, e quindi meno ardua da affrontare?
Insomma, ci sono veramente molti anelli che non tengono, in questo assetto della prova scritta di italiano: una gabbia nella gabbia, dove diventa veramente difficile la missione di un insegnante che desideri, come recita il D.M. 26 agosto 1981, offrire al candidato una "proficua scelta".
Stendere le tracce… la strategia del buon viso a cattivo gioco
Nella ideazione e formulazione delle tracce l'aspirazione dei docenti sarebbe quella di offrire proposte di lavoro che diano a tutti la possibilità di esprimersi al meglio, che gli alunni con meno dimestichezza nella scrittura riescano ad affrontare senza troppi timori, ma che al tempo stesso non risultino piatte e banali per quelli, per così dire, "più bravi". Anche perché, a voler essere sinceri, la banalità è demotivante per tutti, bravi e meno bravi.
Non è un compito facile: bisogna cercare per quanto possibile di calare lo schema proposto dal Ministero nella realtà delle proprie classi. È utile e prezioso ripercorrere mentalmente i tre anni vissuti insieme ai nostri alunni, alla ricerca degli spunti più adatti attorno ai quali costruire una traccia possibile, che corrisponda a uno dei modelli a cui ci si deve attenere.
Per esempio, il modello "classico" della relazione, che deve essere riferito a "un argomento di studio, attinente a qualsiasi disciplina", finisce per suonare così:
Scrivi una relazione su un'attività svolta a scuola o su un'uscita didattica in cui ti sei sentito particolarmente interessato/a e coinvolto/a. Indica l'argomento, dove e con chi l'hai praticata, il metodo seguito, gli strumenti utilizzati, gli obiettivi che dovevi raggiungere, le fasi di lavoro e/o le regole che hai seguito, le difficoltà incontrate e come le hai affrontate, i risultati ottenuti. Dai un giudizio sull'attività e suggerimenti su come potrebbe essere migliorata.
Questa è una traccia molto lineare, che lascia ampia facoltà di scelta agli alunni rispetto all'attività da descrivere, e racchiude già in sé una sorta di scaletta in embrione: tutti elementi che in teoria dovrebbero renderla una traccia facile. In realtà è una traccia senz'anima e senza spina dorsale; potrebbe essere rivolta a chiunque, non c'è nulla che la caratterizzi, nulla che parli davvero in seconda persona, nulla che possa far scattare la scintilla e far pensare a un qualunque alunno "Questo è il tema che fa proprio per me!". L'insegnante, che ben conosce la storia di una certa classe, è l'unico che può sapere come accenderla, una scintilla, anche in una tipologia di tema tradizionale e "spenta" come la relazione. Per esempio, modellando la traccia attorno a un'esperienza autentica che si è visto aver lasciato un segno nei ragazzi. Come nelle tracce che seguono:
- Durante l'anno, con l'insegnante di educazione tecnica ti è sicuramente capitato di costruire degli oggetti. Racconta questa tua esperienza, stendendo una relazione che metta in evidenza perché è stato scelto proprio quell'oggetto, le sue caratteristiche, le fasi del lavoro. Concludi con una valutazione personale per spiegare il valore che questa attività ha avuto per te.
- Con l'insegnante di lettere, nel corso di quest'anno hai trattato, sia in storia sia in geografia, l'argomento del colonialismo. Esponi le tue conoscenze su questo fenomeno in una relazione che comprenda il tempo storico in cui si è manifestato, le cause e i principali protagonisti. Descrivi poi in quale modo l'argomento è stato trattato in classe, descrivendo i metodi seguiti, le attività svolte e quello che ti hanno lasciato.
- Nel corso di questi tre anni, con i tuoi insegnanti hai avuto modo di frequentare il laboratorio di scienze. Presenta uno degli esperimenti che avete realizzato. Quali metodologie avete usato? In quali momenti si è sviluppato? Quali i materiali utilizzati? I risultati sono stati quelli attesi? E soprattutto: che cosa hai imparato alla fine del lavoro?
Naturalmente, se si prendono in considerazione le altre due tipologie di tema, le possibilità di adattamento sono ancora più ampie. Va da sé che la traccia argomentativa andrà a toccare tematiche e fenomeni che sono stati trattati in classe, scegliendoli tra quelli che si sono dimostrati più "sensibili", rispetto ai quali la discussione è stata più ricca e accesa, e che hanno maggiormente contribuito alla crescita personale dei ragazzi. In terza media, non possiamo aspettarci da loro competenze da editorialista: conta soprattutto quello che hanno appreso nel corso dei tre anni, e come sono in grado di ragionarci attraverso lo strumento della scrittura. Inutile allora proporre tracce vaghe e fumose su ecologia, razzismo o globalizzazione, se questi temi, in un qualche momento della quotidianità scolastica, non si sono trasformati per loro in esperienza intellettuale in atto: in discussione, in confronto, in ascolto attivo e partecipazione. La traccia che verrà proposta di tale esperienza dovrà recare un qualche segno, ben riconoscibile. In questo modo lo svolgimento può diventare una sorta di "risposta", e la scrittura una specie di dialogo: come dovrebbe essere sempre, anche a scuola, seguendo la sua più profonda e autentica vocazione comunicativa.