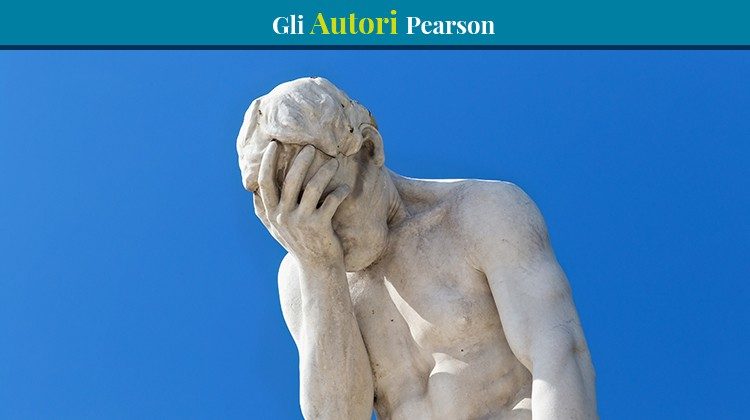Margherita Guidacci: poesia come profezia

Uno sguardo femminile sulla storia
APPROFONDIMENTI DISCIPLINARI – II GRADO
La letteratura di impegno e testimonianza civile non è prerogativa esclusiva degli uomini: ne è un esempio la poesia di Margherita Guidacci, che nelle sue raccolte affronta la barbarie della guerra, dei genocidi e del terrorismo con voce sgomenta e straziante.
di Giuseppe Langella
«Maschio e femmina li creò»
Permettetemi di prendere le mosse dal racconto biblico della creazione di Adamo ed Eva; anzi, al plurale, dai racconti, perché, come sa chiunque abbia qualche dimestichezza con le Scritture, nel libro della Genesi i racconti, in proposito, sono due. Nel più lungo (Gen 2, 18-23) si legge che Dio, volendo dare all’uomo «un aiuto che gli sia simile», fa scendere un torpore su Adamo, gli toglie una costola e intorno ad essa plasma la donna; poi la conduce ad Adamo, che la riconosce «carne dalla sua carne e osso dalle sue ossa». Nell’altro racconto, racchiuso in un solo versetto (Gen 1, 27), viene messa in risalto, invece, la somiglianza dell’essere umano con Dio («a sua immagine») e si accenna, piuttosto, alla complementarità dei generi: «maschio e femmina li creò». Un racconto, dunque, sottolinea l’identità della specie, con tutto ciò che essa comporta sul piano giuridico non meno che ontologico, mentre l’altro pone l’accento sulle differenze di genere, con riferimento alle specificità esistenziali non meno che fisiche e biologiche, previste affinché uomini e donne si completino a vicenda, in un rapporto fecondo di integrazione e di sussidiarietà.
Una favola in forma di apologo
Intorno a queste differenze di genere, Raffaele Crovi concepì una stimolante favola antropologica in forma di apologo, Fuori del Paradiso (1982), dove passava in rassegna, in chiave contrastiva, tutta una serie di caratteristiche, prerogative e inclinazioni riconducibili alla natura maschile o a quella femminile. I suoi Adamo ed Eva, infatti, reagiscono diversamente ai medesimi stimoli, obbedendo a modalità e procedure complementari di interazione con l’ambiente e di soluzione dei problemi: «lui attratto dalla realtà, lei guidata dall’immaginazione, lui curioso della materia, lei calamitata dal linguaggio corporale». Basti citare l’ultimo, emblematico, episodio: l’uomo va in cerca di nidi per rubarne le uova e offrirle in cibo alla donna; ma questa, anziché nutrirsene, mossa da un oscuro sentimento materno, le deposita «sull’erba ancora tiepida di sole, le copre con le sue mani e invita l’uomo a stendere anche le sue, per raddoppiare il calore che le avrebbe fatte dischiudere».
Una peculiare facoltà di sguardo
Disegnando queste due parabole speculari, l’una il rovescio dell’altra, Crovi suggeriva di guardare alle differenze tra uomo e donna nella prospettiva di un arricchimento (e di un completamento) reciproco. Ma, al di là della sua suggestiva ricognizione sui due emisferi dell’essere umano, la letteratura femminile conferma ad abundantiam l’esistenza di quella peculiare facoltà di sguardo sulla vita e sulle cose che costituisce il proprium della donna. Si veda, ad esempio, come Elsa Morante racconta, al termine della Storia, la morte del piccolo Useppe a partire dai presentimenti viscerali della madre: pagine che nessun uomo mai avrebbe saputo scrivere. E valga anche il caso sintomatico di due poetesse come Patrizia Valduga e Franca Grisoni: difficile immaginare qualcosa di più diverso tra Cento quartine e altre storie d’amore della prima e Fiat o Compagn della seconda; eppure il modo in cui nei testi dell’una come in quelli dell’altra viene rappresentata la relazione col partner reca i tratti inconfondibili della femminilità. In quanto rispecchia il punto di vista di una donna, la letteratura femminile ha prodotto un significativo incremento sul piano conoscitivo, guadagnando alla percezione e all’intelligenza del mondo aspetti del reale, risvolti dell’esperienza, vissuti, valori e sentimenti lontani dal campo visivo della letteratura maschile.
Codice genetico e fattori culturali
Peraltro, non sempre le visioni collaterali che poetesse e scrittrici hanno riversato nelle loro opere dipendono dalla loro identità sessuale: spesso derivano, piuttosto, da fattori e modelli culturali, ovvero dalle funzioni attribuite alla donna e dalla posizione che essa ha via via ricoperto nella compagine sociale. Se, in altri termini, la letteratura femminile ha privilegiato, tante volte, la sfera dei sentimenti, la dimensione romantica del sogno e i grandi temi dell’amore, della maternità, della famiglia, della casa, della seduzione, della violenza e dell’emancipazione, è stato anche a motivo di un sistema patriarcale che la relegava al ruolo di moglie, di allevatrice della prole e di angelo del focolare. E tuttavia, pur con la consapevolezza dell’origine non genetica ma culturale di certe sensibilità, tutte le rappresentazioni della vita scaturite da uno sguardo femminile sono comunque interessanti, se non altro come riflesso, non di rado problematico, di una particolare condizione storica.
Lo sguardo femminile sulla Storia
Ma lo sguardo femminile non si è esercitato unicamente sulla sfera privata, e magari intima, dei rapporti affettivi e dei legami ombelicali; al contrario, si è posato anche, con viscerale empatia, sui drammi della Storia, schierandosi immancabilmente dalla parte delle vittime innocenti e agendo sulle leve tragiche dell’orrore e della pietà. Lo abbiamo già verificato, ad esempio, nella Storia di Elsa Morante («uno scandalo che dura da diecimila anni») e lo possiamo ritrovare, con accenti oracolari e profetici, anche nei versi di Margherita Guidacci, una delle voci femminili più riconoscibili del Novecento, dove si fa largo a più riprese, davanti alle barbarie della guerra, dei genocidi e del terrorismo, la corda civile dello sgomento e dell’esecrazione, dello strazio e del compianto. Valore a parte, segnalo questa poetessa proprio per documentare il fatto che la letteratura di impegno e testimonianza civile non è appannaggio esclusivo degli uomini e per mostrare, al contempo, la peculiarità femminile dell’accento.
Margherita Guidacci
Margherita Guidacci, nata a Firenze nel 1921, rimase orfana di padre all’età di dieci anni. Si laureò in Lettere con Giuseppe De Robertis discutendo una tesi sulla poesia di Ungaretti. Innamoratasi di Emily Dickinson e di Thomas S. Eliot, cominciò a studiare l’inglese, traducendo anche parecchi poeti e scrittori. Come poetessa esordì nel 1946 con La sabbia e l’angelo, dove tentava di «dominare, esprimendolo, il devastante senso di morte che aveva gravato» su di lei «nei terribili anni della guerra». Seguì, nel 1954, Morte del ricco, un oratorio ispirato alla parabola evangelica del povero Lazzaro e del ricco Epulone. Un senso di pochezza e di caducità pervade anche la raccolta del 1961, intitolata non a caso Paglia e polvere. Nel 1958 la Guidacci si trasferì, col marito e i figli, a Roma. Insegnò nei licei fino al 1976, quando ottenne la cattedra universitaria di Letteratura anglo-americana. Una crisi coniugale le procurò una grave sofferenza nervosa, che richiese il ricovero temporaneo in una clinica. A questa dolorosa esperienza fanno riferimento Neurosuite (1970) e Terra senza orologi (1973). Rimasta vedova nel 1977, la Guidacci si rasserenò negli anni ottanta, in seguito all’incontro fortuito, su un treno, con l’uomo di cui si era innamorata da ragazza e di cui aveva perso i contatti dopo che questi era emigrato in America Latina. Dal riannodarsi di quella tenera relazione scaturirono l’Inno alla gioia (1983) e Il buio e lo splendore (1989). Colpita da un ictus nel gennaio 1990, morì due anni dopo a Roma, non prima di aver consegnato all’editore un’ultima raccolta, Anelli del tempo (1993).
Un’interminabile Via Crucis
Nei versi di Margherita Guidacci il tema civile s’intreccia sempre con l’immaginario biblico, alimentando un’accorata meditazione religiosa sui fatti di cronaca e sulle vicende storiche. La poetessa ricorda infatti, in un’intervista del 1971, che «la Bibbia è stata per lei una delle letture fondamentali, fatta molto presto nella sua giovinezza e rimastale dentro», per il valore paradigmatico di «certe situazioni che oltre alla loro drammaticità storica sono anche dei simboli mirabili per esprimere come l’uomo si può sentire sulla terra». Ciò che più ferisce la sensibilità della Guidacci è la violenza sanguinaria che perpetua il gesto omicida di Caino, rievocato già in un testo di Neurosuite: «è un solo grido / che continua nel tempo – ed Eva ancora / urla su Abele mentre ad Hiroshima / la torva cenere disegna nell’aria / l’ultima clava di Caino» (Gridi). Questo motivo acquista una centralità cruciale soprattutto nelle opere pubblicate nei cosiddetti “anni di piombo”. Nella raccolta del 1977, Il vuoto e le forme, la Guidacci leva una voce ferma di protesta contro il golpe militare che quattro anni prima aveva rovesciato, in Cile, Salvador Allende e perseguitato i suoi sostenitori, con decine di migliaia di arresti e di desaparecidos; mentre L’orologio di Bologna, composto a ridosso dell’attentato terroristico del 2 agosto 1980, è un commosso requiem per le vittime della strage e vibra di indignazione di fronte a tanto lucida e perversa follia assassina. E se la minaccia di una guerra nucleare, in tempi di corsa agli armamenti, aleggia perfino nei pannelli poetici dell’Altare di Isenheim (1980), ispirati al celebre polittico di Grünewald, la Via Crucis dell’Umanità, commissionata alla poetessa da padre Massimiliano Rosito nel 1984, nelle sue canoniche 14 stazioni passa in rassegna, sulla scia del primo fratricidio, alcuni tra i crimini più mostruosi della Storia: la strage degli innocenti ordinata da Erode, lo sterminio degli Incas e degli Indios, lo schiavismo, la shoah, la bomba atomica e l’uccisione di tanti che si sono battuti per la giustizia e per la pace, dai martiri cristiani dati in pasto alle «belve nell’arena» fino a padre Kolbe, a Gandhi, a Kennedy, a Martin Luther King. Nel cuore di questa visione c’è, naturalmente, in prospettiva cristiana, lo scandalo della croce, o per dir meglio, il «mistero di dolore» del Figlio di Dio appeso al legno che col suo «sacrificio» dona al mondo la «salvezza», prefigurata nel Gesù risorto dell’ultima stazione.
Donna dei dolori
Margherita Guidacci assume su di sé tutti i patimenti e le angosce del mondo e li raggruma nei suoi versi, come l’Ostrica perlifera di Neurosuite, cui «basta un opaco granello di sabbia / e intorno il suo dolore iridescente». Ciò che colpisce nell’opera poetica della Guidacci è la visceralità del sentimento. Le atrocità della Storia diventano in lei dolore fisico, orrore e strazio, ferite laceranti. La sua poesia civile nasce dal dolore e ne è intrisa, dà voce all’angoscia, è il dolore che si fa carne e parola.
L’urgenza testimoniale che ne deriva libera molto presto la Guidacci da ogni ipoteca ermetica. A buon diritto, perciò, nella scheda autobiografica che scrive per l’antologia della Poesia italiana contemporanea (1909-1959) curata da Giacinto Spagnoletti (Guanda, Parma 1964, pp. 797-801) la Guidacci può dichiarare che i suoi «interessi erano soprattutto di contenuto; le parole per lei valevano per il loro senso ordinario e corrente, di scambio, non per un soprasenso demiurgico che le isolasse dal resto del linguaggio». Essa rinuncia alla parola epifanica cara ad Ungaretti e all’ermetismo fiorentino, non insegue «un accostamento magico di suoni», ma «un accostamento drammatico di significati».
Poesia come profezia
Assunti in un orizzonte religioso e filtrati attraverso il testo biblico, i temi civili toccati dalla Guidacci prendono sulla pagina un tono solenne, ieratico, ispirato, secondo il modello scritturale dei libri profetici. La poetessa si assegna volentieri questa funzione oracolare, sentendosi investita di un compito molto vicino alla dimensione del sacro. Non per nulla, l’ultima raccolta pubblicata in vita, Il buio e lo splendore, si apre con un’ampia e quanto mai suggestiva sezione di Sibyllae, in cui, identificandosi con queste antiche profetesse, la Guidacci ricorda, fra l’altro, la matrice divina dei loro responsi: «È luminoso il dio / che parla per mia bocca» (Delfica III). Ma la Guidacci è poi tutt’altro che sibillina nei giudizi che pronuncia sulle aberranti vicende della Storia. Nessuna oscurità nei suoi versi, nessuna ambiguità: il suo dire può essere, a volte, allegorico e allusivo, ma è assolutamente univoco, ha la nettezza di un autodafé; come quando, ad esempio, nell’Altare di Isenheim accusa non già «il sonno / della ragione», ma «la sua veglia», di essere diventata «l’artefice stessa del nostro male», che ormai «cresce in laboratorio e non nella foresta», che «ha per emblema non l’animale ma la macchina», «per armi non più rostri, zanne, artigli, / ma bombe, gas, elettrodi», e «per ultimo traguardo / non la profonda notte a cui scendono dèmoni e belve, / ma un gran sole mortale sul mondo scardinato» (Tentazione di Sant’Antonio).
Referenze iconografiche: Alexey Pevnev / Shutterstock
Bibliografia essenziale
• Margherita Guidacci, Le poesie, a cura di Maura Del Serra, Le Lettere, Firenze 1999.
• Margherita Guidacci, Prose e interviste, a cura di Ilaria Rabatti, Editrice CRT, Pistoia 1999.
• Margherita Pieracci Harwell, La poesia di Margherita Guidacci: origini e sviluppo, in «Annali di Italianistica», VII (1989), pp. 354-381.
• Maria Teresa Rossignoli, L’impegno civile nella poesia di Margherita Guidacci, in «Città di Vita», XLIV (1993), 6, pp. 257-265.
• Per Margherita Guidacci, Atti delle giornate di studio (Firenze, 15-16 ottobre 1999), a cura di Margherita Ghilardi, Le Lettere, Firenze 2001.
• Maura Del Serra, Le foglie della Sibilla. Scritti su Margherita Guidacci, Studium, Roma 2005.
• Anna Maria Tamburini, «Più che la morte». La sapienza biblica nei versi di Cristina Campo, Margherita Guidacci, Agostino Venanzio Reali, in Massimo Naro (a cura di), Mi metto la mano sulla bocca. Echi sapienziali nella letteratura italiana contemporanea, Città Nuova, Roma 2014, pp. 129-176.
• Preghiere per la notte dell’anima, Convegno di Studi su Margherita Guidacci, Edizioni Feeria, Panzano in Chianti 2019.
In evidenza
Guarda la videolezione dedicata ad Margherita Guidacci >>
Il canale YouTube per la didattica della modernità letteraria
Una videoteca a servizio di docenti e studenti, comprensiva anche di un’ulteriore sezione dedicata a commenti e analisi testuali, che costituiscano una sorta di ideale antologia scolastica.
Per vedere la precedente videolezione vi invito a cliccare qui: Amelia Rosselli >>
Per iscrivervi al canale vi invito a cliccare qui: Giuseppe Langella >>
Per una veloce videopresentazione vi rimando invece qui: Un canale YouTube per la didattica della modernità letteraria >>