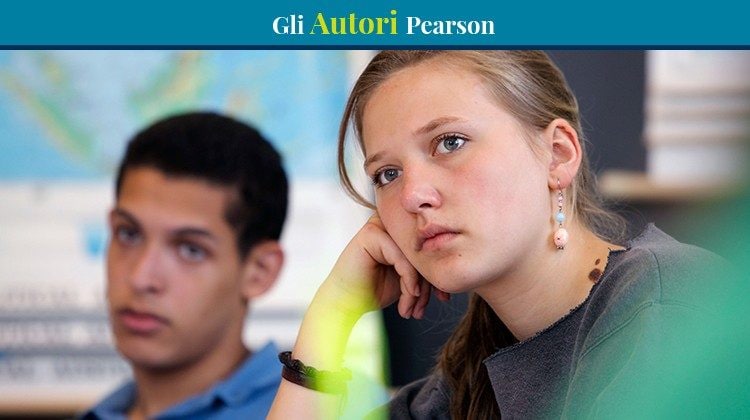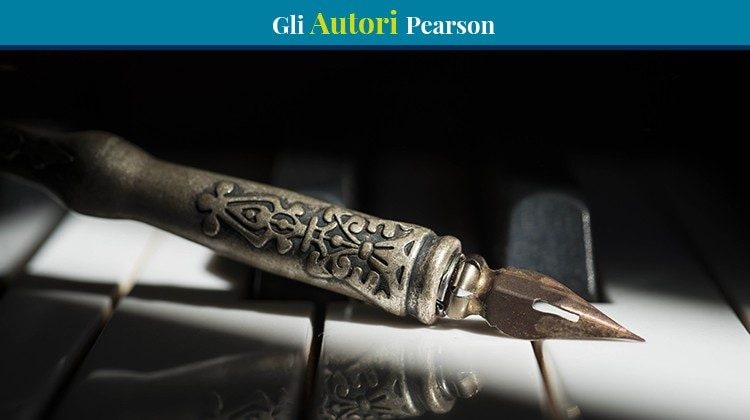Amelia Rosselli, tra poesia e musica

Un percorso tra i componimenti della poetessa
APPROFONDIMENTI DISCIPLINARI – II GRADO
Spirito apolide, padronanza di tre lingue e una formazione musicale che lascia il segno nella sua poesia: questo e molto altro è Amelia Rosselli, poetessa capace di dare forma all’inconscio.
di Giuseppe Langella
Poete o poetesse? Le implicazioni di una desinenza
Da che mondo è mondo, il femminile di “poeta” è sempre stato “poetessa”. Ma negli ultimi tempi, tra gli addetti ai lavori è venuto di moda dire “una poeta”, onde, che so io, Alda Merini sarebbe “la poeta dei Navigli”. Sembra addirittura che la desinenza in -essa non sia più politically correct, quasi fosse diventato un insulto chiamare “poetesse”, per esempio, Antonia Pozzi o Maria Luisa Spaziani. Per quanto mi riguarda, invece, ritengo che “una poeta” sia non solo un ridicolo, inascoltabile, barbarismo che fa a pugni con l’origine e la morfologia del termine, ma anche una trovata infelice e nociva.
La sottile discriminazione dei titoli al maschile
Nell’atto stesso di conferire un titolo maschile (direttore, avvocato, architetto, capitano ecc.) a una donna che si è meritata un’alta carica o la stima universale, si finisce per confermare, paradossalmente, l’inferiorità del suo genere di appartenenza, come se le si dicesse: «Sei bravissima benché donna», sentenza odiosamente maschilista e infamante. Se, infatti, a dare autorevolezza e prestigio a una carica o a una funzione sono le qualità della persona che la ricopre o la esercita, indipendentemente dal fatto che sia uomo o donna, allora non si vede perché la carica e la funzione debbano avere una desinenza invariabilmente maschile. Ci se ne renda conto o meno, applicare a una donna un titolo maschile è infliggerle una sottile discriminazione, quasi stesse usurpando un posto riservato agli uomini.
Un errore ideologico, prima ancora che grammaticale
Ciò vale anche per “poeta”, perché, non diversamente dai titoli sopra menzionati (come anche deputato, vigile, preside o professore), “poeta” non è un sostantivo neutro ma un nome di genere maschile. In questo senso, chi dice “una poeta” credendo di difendere la giusta causa femminile, in realtà non fa che ribadire, senza volerlo, che la poesia è una prerogativa maschile. Dire “una poeta” non è solo un errore grammaticale (che sarebbe il minimo), ma anche e più ancora un errore ideologico, un’aporia politicamente squalificante. Non siamo più nel Novecento, siamo entrati ormai in una fase culturale in cui la distinzione morfologica tra “poeta” e “poetessa” non evoca più due graduatorie, due differenti scale di valori. La desinenza femminile ha perso, finalmente, qualsiasi connotazione riduttiva, dichiarando invece, semplicemente, un dato anagrafico concernente l’identità di genere e annunciando, semmai, il valore aggiunto di quella peculiare facoltà di sguardo sulla vita e sulle cose che appartiene alla natura e alla coscienza della donna. Continuare a vergognarsi, perciò, del titolo di “poetessa” mi sembra, oggi, francamente anacronistico, un inerte retaggio del passato. Chi dice “una poeta” tradisce un complesso di inferiorità che nel terzo millennio non ha più ragione d’esistere, condannandosi da sé a una posizione di retroguardia.
Va da sé, allora, che parlando di Amelia Rosselli, la fuoriclasse di questa puntata, la definirò un’eccellente “poetessa”.
Amelia Rosselli
Figlia di Carlo Rosselli, militante antifascista ucciso in esilio in Francia nel giugno del 1937 assieme al fratello Nello, Amelia Rosselli nacque a Parigi il 28 marzo del 1930. Con la madre inglese, dopo l’assassinio del padre, si trasferì in Svizzera, in Inghilterra e negli Stati Uniti, sviluppando uno spirito apolide. In Inghilterra, fra l’altro, completò i propri studi letterari, filosofici e musicali. Dopo la fine della guerra, comunque, scelse di stabilirsi a Roma, dove trovò lavoro come traduttrice. Dal trauma dell’assassinio politico del padre e dello zio che l’aveva resa orfana non riuscì mai a sollevarsi: assediata da deliranti manie di persecuzione, cedette infine alla paranoia che da sempre la faceva sentire minacciata, gettandosi dalla finestra dell’appartamento in cui risiedeva. Era l’11 febbraio del 1996.
Dare espressione e forma all’inconscio
Amelia Rosselli fece della poesia l’espressione incandescente delle sue paure e lacerazioni interiori. A questo disordine, che fluiva direttamente dal suo inconscio, la poetessa cercò di dare un ordine se non altro prosodico, introducendo in poesia il concetto musicale di “durata”, che le veniva dalla sua competentissima educazione in quel campo.
L’originalità della Rosselli balza all’occhio se confrontiamo la sua opera con i testi dei Novissimi. Lo sperimentalismo che sostanzia la sua poesia, infatti, è di natura molto diversa dalle ricerche avviate in quegli stessi anni dalla Neoavanguardia, perché non mira a scardinare, denunciandole, le ideologie sottese a ogni linguaggio, alla maniera del Gruppo 63, ma a far emergere, convogliati in una forma, i turbamenti, gli stridori e le movenze dell’inconscio. Sta qui, appunto, nell’aver saputo dare espressione verbale e argine metrico ai vissuti profondi, la paradigmaticità, la forza canonizzante, di questa poetessa.
Variazioni Belliche
Introdotta da un’illuminante Notizia di Pier Paolo Pasolini, la prima raccolta di Amelia Rosselli, Variazioni Belliche, uscì nel 1964 per Garzanti. «Variazioni» rimanda al procedimento tipicamente musicale della ripresa ogni volta variata di un tema armonico, mentre l’aggettivo «belliche», tremendamente ambiguo nel suo evocare il bellum, la guerra, ma anche, per omofonia, la bellezza, allude a una materia conflittuale ora tragicamente storica (le persecuzioni politiche e razziali, la guerra e la Resistenza), ora privatamente erotico-amorosa (il rapporto, in particolare, con Rocco Scotellaro, scrittore e poeta lucano, fervente meridionalista e sindaco di Tricarico). Non stupisce, in tal senso, che diversi componimenti attacchino con la preposizione impropria “contro”. Questo antagonismo di fondo trova il suo corrispettivo linguistico nelle forme del contrasto, dell’antitesi e dell’ossimoro.
Attraverso un dettato quasi salmodiante, onirico, oracolare, fitto di anafore, parallelismi, echi e lapsus, l’autrice porta allo scoperto il magma che ribolle nella propria anima, rielaborando le ferite dell’esperienza con accenti arroventati, non di rado sostenuti da un’intonazione creaturale o mistica. Ha osservato, giustamente, Pier Vincenzo Mengaldo che l’«abbandono al flusso buio e labirintico della vita psichica e dell’immaginario» proprio della poesia di Amelia Rosselli produce «l’abolizione di ogni confine fra interno ed esterno, privato e pubblico-sociale». La poetessa ci trasmette, così, «in modo lancinante la percezione della normalità dell’orrore».
Serie Ospedaliera
Il secondo libro poetico di Amelia Rosselli, Serie Ospedaliera, uscì per Il Saggiatore nel 1969. I testi raccolti nella sezione da cui prende il titolo sono preceduti da un poemetto in 28 lasse di misura assai elastica, La Libellula (Panegirico della Libertà). Il tema attorno a cui ruota il poemetto, come suggerisce il sottotitolo, è quello della Libertà, cui si aggiunge quello connesso della Giustizia che chiama al dovere dell’impegno civile. Non si dimentichi che il padre e lo zio di Amelia avevano fondato il movimento “Giustizia e Libertà”.
I testi della sezione eponima di Serie Ospedaliera, datati 1963-1965, refertano una fase ulteriore rispetto a Variazioni Belliche. Ridotta a mal partito dagli scontri documentati nella raccolta precedente, la poetessa accede a un nosocomio per farsi curare. Dei progressi temporaneamente compiuti è specchio l’allentamento progressivo della tensione formale, tanto metrica quanto stilistica, e l’instaurarsi di un confronto meno agonistico, anzi quasi riconciliato, con la tradizione, inclusi Petrarca e Saba, spie di un’apertura al canone più squisitamente lirico e cantabile, in cui dare sfogo alla solitudine e alla crisi di abbandono di un io innamorato.
Documento
Nelle intenzioni della Rosselli Documento (1966-1973), pubblicato da Garzanti nel 1976, avrebbe dovuto rappresentare il punto d’arrivo della sua ricerca poetica, enfatizzando gli aspetti formali dell’elaborazione. E indubbiamente i primi testi tengono fede a questo proposito: l’impaginazione cronologica della raccolta mostra infatti, specialmente nel tratto iniziale, la conquista di una misura classica, di un nuovo raggiunto equilibrio. Senza scimmiottare, beninteso, le forme canoniche della tradizione, e semmai camuffandole, l’autrice si dà ogni volta delle regole, cercando nella geometria delle forme chiuse un argine a un’effusività altrimenti fuori controllo.
Col tempo, però, e sotto l’incalzare degli eventi storici (il Sessantotto e il terrorismo stragista), le spinte centrifughe prendono il sopravvento, mandando in frantumi il progetto, con l’abbandono degli schemi strofici e una più accentuata frammentarietà dei componimenti. Le delusioni della Storia fanno toccare con mano all’autrice la distanza incolmabile che separa la poesia, protesa verso il sublime, e l’inganno di un’«inaccettabile realtà».
Impromptu
Pubblicato nel 1981 nelle raffinate edizioni di San Marco dei Giustiniani, Impromptu è un poemetto composto tutto d’un fiato, a detta dell’autrice, in una sola giornata, l’8 dicembre 1979, dopo anni, se non proprio di silenzio assoluto, di prove abbastanza inconcludenti. Il titolo, di pertinenza ancora una volta musicale, che richiama l’improvvisazione di un brano strumentale, soprattutto pianistico, affidata insieme all’estro e al mestiere, allude proprio a questo momento di furor compositivo, più romantico, a dire il vero, che manieristico, nel caso della Rosselli. Anche se i temi sono quelli di sempre, legati a un’idea dell’esistenza come campo di battaglia, l’euforia per il riemergere inatteso dell’ispirazione conferisce al poemetto un’energia selvaggia, ravvisabile anche nel ritmo veloce, quasi rapinoso, dei versi, e una maggiore apertura ai temi civili degli anni Settanta.
Le tre lingue di Amelia Rosselli
Uscito per Guanda nel 1980, Primi Scritti raccoglie i documenti più antichi della vocazione letteraria di Amelia Rosselli: testi in prosa e in versi risalenti al periodo 1952-1963. Quel che colpisce maggiormente, di questo tirocinio espressivo, è l’oscillazione linguistica tra il francese, lingua della fanciullezza parigina, l’italiano, lingua paterna e domestica, e l’anglo-americano, lingua della madre, dell’ulteriore esilio negli anni della guerra e degli studi superiori della futura poetessa. Caso limite: il Diario in tre lingue (1955-1956), in cui italiano, francese e inglese si avvicendano continuamente, talvolta persino all’interno di un medesimo appunto. Ma anche la cronologia delle altre sezioni evidenzia le stesse oscillazioni, come se la Rosselli saggiasse le potenzialità delle tre lingue senza riuscire a risolversi per l’una o per l’altra.
Tra le tre lingue, alla lunga, ha vinto la competizione certamente l’italiano, ma le 88 poesie di Sleep (Garzanti 1992), scritte in inglese tra il 1953 e il 1966 ed estratte, peraltro, da un più corposo dattiloscritto, testimoniano di un’esitazione protrattasi a lungo, ben oltre la fase di apprendistato. Sleep ci restituisce l’immagine forse più privata della Rosselli, legata a una passione amorosa che conosce il desiderio e la delusione, la disperazione e la protesta, nel segno di una risentita e un po’ folle e un po’ clownesca femminilità, che affronta in duello un amante dai tratti ambiguamente e pericolosamente divini.
Referenze iconografiche: Angelica Colombini / Shutterstock
Bibliografia essenziale
• Amelia Rosselli, L’opera poetica, a cura di Stefano Giovannuzzi, Arnoldo Mondadori, Milano 2012.
• Silvia De March, Amelia Rosselli tra poesia e storia, L’Ancora del Mediterraneo, Napoli 2006.
• Tatiana Bisanti, L’opera plurilingue di Amelia Rosselli, ETS, Pisa 2007.
• Antonio Loreto, I santi padri di Amelia Rosselli. “Variazioni Belliche” e l’avanguardia, Arcipelago Edizioni, Milano 2013.
• Laura Barile, Avvicinamento alla poesia di Amelia Rosselli, Pacini Editore, Ospedaletto 2015.
• Stefano Giovannuzzi, Amelia Rosselli: biografia e poesia, Interlinea, Novara 2016.
• Pier Vincenzo Mengaldo, Amelia Rosselli, in Poeti italiani del Novecento, Arnoldo Mondadori, Milano 1978 (I Meridiani), pp. 993-997.
In evidenza
Guarda la videolezione dedicata ad Amelia Rosselli >>
Il canale YouTube per la didattica della modernità letteraria
Una videoteca a servizio di docenti e studenti, comprensiva anche di un’ulteriore sezione dedicata a commenti e analisi testuali, che costituiscano una sorta di ideale antologia scolastica.
Per vedere la precedente videolezione vi invito a cliccare qui: Elsa Morante >>
Per iscrivervi al canale vi invito a cliccare qui: Giuseppe Langella >>
Per una veloce videopresentazione vi rimando invece qui: Un canale YouTube per la didattica della modernità letteraria >>