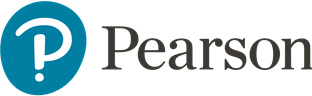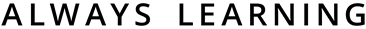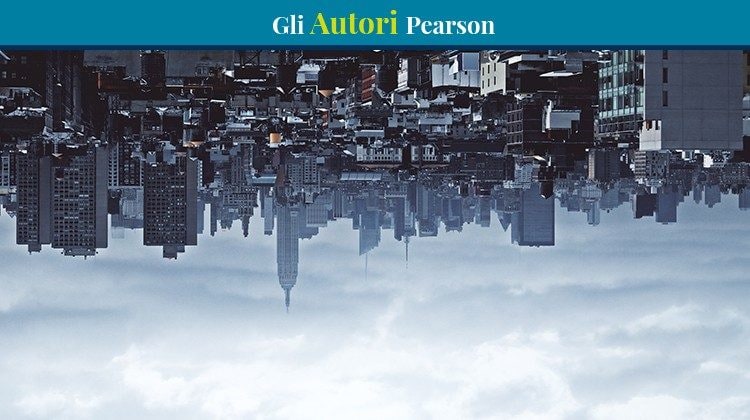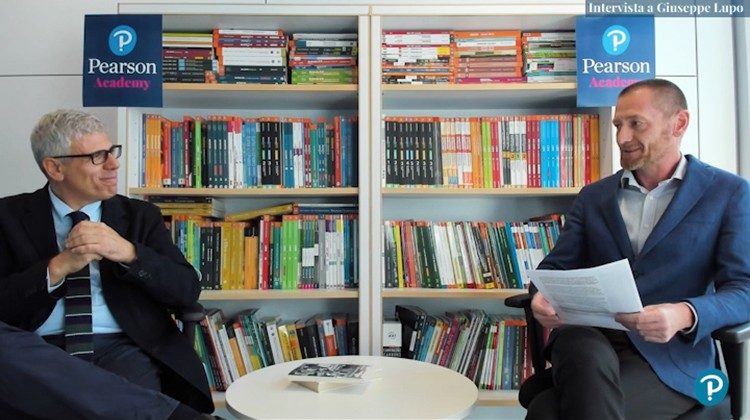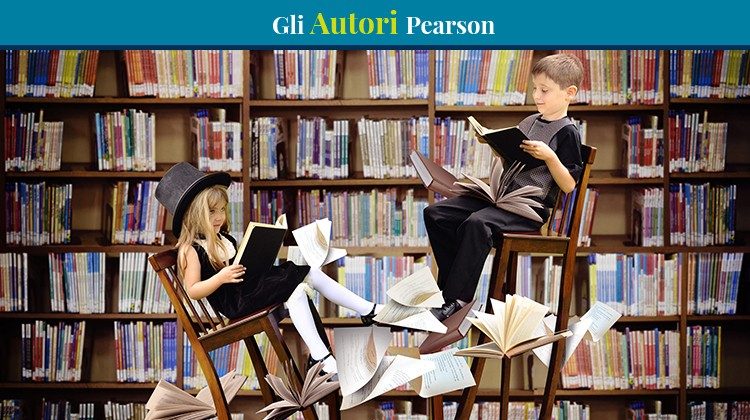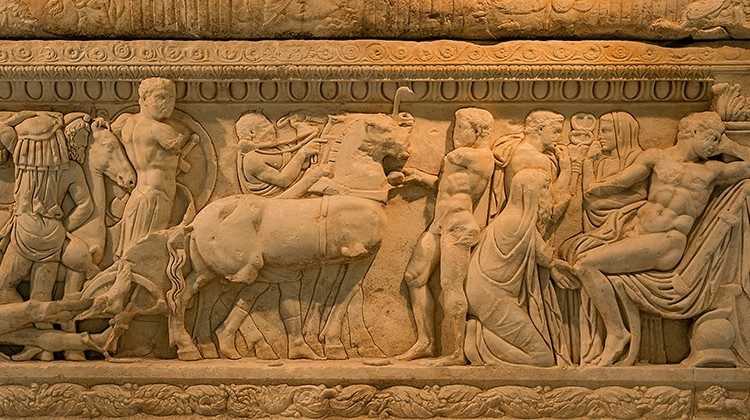
2. Il vero inverosimile
Qualcosa di simile avviene anche a livello di concatenazione degli eventi. Pirandello accredita una visione accidentale delle vicende umane, diventando tutto egualmente possibile nel momento in cui il prodursi dei fatti non appare più regolato da una legge deterministica di causalità, ma soggetto alle bizzarrie del caso. Ai critici che avevano creduto di poterne screditare il romanzo osservando che la storia narrata nel Fu Mattia Pascal era del tutto inverosimile, Pirandello replica con una memorabile Avvertenza sugli scrupoli della fantasia, allegata all’edizione Bemporad del 1921, in cui ha buon gioco a ritagliare un articolo di cronaca apparso nel frattempo sul «Corriere della Sera», che presentava una somiglianza «veramente eccezionale, fin nella minuzia di certi caratteristici particolari»12, con la fabula di sua invenzione. In questo modo, la vicenda effettivamente bizzarra del suo personaggio serve ad avvalorare l’idea di una vita piena delle più sfacciate assurdità, che «non hanno bisogno di parer verosimili, perché sono vere»13. Solo in astratto – incalza Pirandello – si può concepire un’idea universale di uomo; nella realtà esiste un’infinita varietà d’uomini, compresi quelli cui capita nella vita «la disgrazia di perdere, poniamo, una gamba e di farsela mettere di legno; di perdere un occhio e di farselo mettere di vetro»14.
L’invasione vittoriosa dei brutti
Non diversamente da Gadda, Pirandello predilige i casi anomali: qui, nella fattispecie, due individui con protesi, che fanno il paio con l’occhio strabico di Mattia Pascal e il naso storto di Vitangelo Moscarda. Potremmo postillare questi esempi davvero sintomatici con un’espressione diventata, più di recente, uno slogan della nuova psichiatria: visto da vicino, nessuno è normale. L’antropologia letteraria di Pirandello sta tutta nel guscio di questa formula. Degli innumerevoli personaggi che affollano le sue opere, a cominciare dai protagonisti delle Novelle per un anno, non si salva praticamente nessuno. Siamo a quella che Giacomo Debenedetti, con una frase rimasta celebre, definì «l’invasione vittoriosa dei brutti, che a non lungo andare occuperanno tutto il territorio»15; anzi, pensando in particolare proprio ai personaggi disegnati da Pirandello e da Federigo Tozzi, fu ancora più esplicito: «A mettere insieme i visi e le figure di quella gente, si ricava poco meno che un’adunata da moderna Corte dei Miracoli»16.
L’unica categoria è quella del possibile
A partire da una visione gelatinosa, non classificatoria, informe (o deforme) del reale, la letteratura del Novecento reintroduce, pertanto, nella rappresentazione di esso una certa dose di caos, a perturbare il cosmo ordinato delle forme tradizionali. Anzi, è proprio per soddisfare l’esigenza di un rispecchiamento integrale della vita, che vengono ripudiati, come contenitori troppo rigidi e angusti, i generi e le poetiche ereditati dal passato anche recente.
Si comprende, allora, nel propagarsi di questo atteggiamento più disarmato e insieme più curioso e disponibile a sospendere il giudizio sopra i confini di una realtà fattasi torbida e sfuggente, la relativa fortuna, nel Novecento, della letteratura “fantastica”, frequentata in Italia da una sequenza ininterrotta di autori di spicco, che vanno da Giovanni Papini ad Alberto Savinio, da Aldo Palazzeschi a Massimo Bontempelli, da Tommaso Landolfi ad Antonio Delfini, da Dino Buzzati a Italo Calvino. È proprio del fantastico, infatti, intrecciare i fili del reale con quelli dell’immaginario fino a confonderli, annettendo con la massima naturalezza alla sfera dell’esperienza comune eventi a dir poco strani e sorprendenti, come se fossero i più normali del mondo. Il lettore viene invischiato in una ragnatela di vicende dove non riesce più a distinguere con sicurezza il sogno dalla veglia, la realtà oggettiva dall’allucinazione, rimanendo a sua volta disorientato. Quello che salta è appunto il criterio statistico della verisimiglianza come discriminante qualitativa per decidere della credibilità o meno del mondo inventato da un autore. Tutto diventa possibile, e quindi credibile, alla stessa stregua. Poco importa se un evento non ha la medesima probabilità di verificarsi di un altro: le categorie di ordinario e straordinario vengono riassorbite nell’unica, indistinta, del possibile.
Del resto, nella letteratura del Novecento, fantastica e non, viene messa fortemente in discussione l’esistenza di una presunta normalità di natura e di comportamento. Lo Svevo della Coscienza di Zeno è convinto che gli organismi viventi, in un senso o nell’altro, siano tutti variamente malati17, mentre il Pirandello di Uno, nessuno e centomila si toglie il gusto, addirittura, di scambiare le parti tra i savii ed i pazzi18. E la coscienza dell’irriducibilità della vita alle vane costruzioni del pensiero e perfino della scienza, come alle gabbie dei luoghi comuni, delle convenzioni sociali e dell’ordine costituito, percorre tutto il Novecento letterario, dal Peccato di Boine (1914) fino a Palomar di Calvino (1983)19. Nell’universo sconvolto della crisi moderna la totalità del reale viene percepita non più come il prodotto di una moltiplicazione all’ennesima potenza di unità sostanzialmente identiche tra loro, cosmi in miniatura contrassegnati dalla medesima cifra che è anche la cifra del mondo; bensì come la somma incalcolabile di fenomeni disparati. Pur collegato agli altri da mille combinazioni, ognuno di essi fa storia a sé. Non esiste più l’universalmente umano, e neppure il carattere o il personaggio che incarna i tratti tipici di un’epoca, di una razza, o di un milieu.
3. Il tragico quotidiano
Analogamente, un’altra millenaria frontiera viene abbattuta, quella che teneva il tragico distinto dal quotidiano. A sancirne, per contro, la fusione provvede Papini fin dal 1906, coniando per il suo primo volume di racconti filosofici la sigla ossimorica, appunto, di Tragico quotidiano. Accade, così, che circostanze comuni, semplici difetti o dettagli insignificanti acquistino un rilievo traumatico, tali da scatenare reazioni violente, veri e propri eccessi; ovvero che tragiche morti, atti di sadismo, situazioni raccapriccianti, passino quasi inavvertiti, come episodi di ordinaria amministrazione, senza minimamente scalfire la coscienza: segno di una grave caduta del senso morale. Si prendano i Ragazzi di vita di Pier Paolo Pasolini (1955) o i 33 racconti del Crematorio di Vienna di Goffredo Parise (1969), i cui personaggi arrivano anzi a introiettare e teorizzare con farneticante lucidità il freddo, determinato, impassibile esercizio della violenza, fino alla soppressione fisica, nelle circostanze e operazioni più abituali della vita moderna.
La violenza, del resto, è abbastanza di casa nella letteratura del Novecento: basta sfogliare le opere di Federigo Tozzi o di Cesare Pavese, o alcune raccolte poetiche di Giorgio Caproni e Andrea Zanzotto, per non parlare della generazione dei cosiddetti "cannibali". Piuttosto, sarà da notare che le sue manifestazioni più caratteristiche erompono da una crudeltà o da una follia fondamentalmente gratuite, come il colpo d’accetta che Berto, un contadino, vibra alle spalle del suo datore di lavoro Remigio, al termine del Podere (1921) di Tozzi20, o l’incendio appiccato ai piedi del Piattoletta, legato al palo della tortura, nei citati Ragazzi di vita di Pasolini21. Ed è proprio questo che rende più inquietante la rappresentazione novecentesca del male, al punto da convertire, se possibile, il terrore della tragedia classica in sgomento. La violenza che si scatena senza motivo, o senza almeno un motivo plausibile, razionale, porta allo scoperto un’umanità degradata, brutale, in preda a impulsi incontrollabili.
Quello che la letteratura contemporanea ci restituisce è dunque, non di rado, un mondo dai tratti largamente infernali, che contrassegnano indistintamente tanto lo stato di civiltà, nei vari aspetti indotti dalla modernizzazione, quanto quello di natura, infinitamente lontano, nonché dall’Arcadia, dai boschi rousseauiani del buon selvaggio. La Saison en enfer (1873) inaugurata da Rimbaud, e prima di lui da Baudelaire, ha conosciuto nel Novecento un’infinità di repliche; con una differenza capitale, però: che mentre quella dei poeti maledetti aveva ancora il profilo di un’avventura sui generis, assolutamente eslege, irregolare, gli autori contemporanei la sentono ormai come una condanna a priori che non risparmia nessuno, una condizione di partenza che essi non hanno chiesto, ma dal cui circolo vizioso, piuttosto, bramerebbero uscire. «La purga dura da sempre, senza un perché», recita un verso di Montale, nel Sogno del prigioniero, a suggello della Bufera (1956)22. L’esperienza di cui Rimbaud aveva circoscritto la durata a una stagione rischia di tramutarsi in un supplizio senza fine.
Un inferno, poi, a maggior ragione, è la vita nel lager raccontata da Primo Levi in Se questo è un uomo (1947), per nulla estranea alla dimensione comune, perché Auschwitz, nella coscienza dell’autore, non rappresenta l’anti-mondo, la deroga barbarica al normale galateo dei rapporti umani, ma la degenerazione del mondo civile quando, in certi frangenti, l’infezione latente23 dell’egoismo e dell’intolleranza, insidia non debellata di ogni contratto sociale, si manifesta in tutta la sua virulenza. Il campo di concentramento è in altri termini, per Levi, un’epifania privilegiata dell’inferno quotidiano, portata dalle circostanze al massimo grado di trasparenza.
Ma anche senza uscire dai confini dell’esperienza ordinaria, Calvino, nell’ultima pagina delle Città invisibili (1972), fa dire a Marco Polo, suo portavoce, che «l’inferno dei viventi» è quello «che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme»24; e Buzzati, dal canto suo, ambienta in una delle odierne metropoli, caotiche, stressanti, frenetiche, anonime, inquinate, assordanti e invase dal traffico, il suo fantastico Viaggio agli inferni del secolo25.
Le cure della psicanalisi
Non è poi così strana, in questo quadro, la tendenza a vivere la quotidianità in termini drammatici, con una reattività esulcerata, sopra le righe. Addirittura parossistico, sotto il profilo del rovello interiore come della condotta, è il quadro clinico che presentano, per esempio, l’iracondo Enrico di Tre croci (1920) di Tozzi, o l’operaio Saluggia, afflitto da manie di persecuzione, cui Paolo Volponi affida la stesura di un turbatissimo Memoriale (1962), o ancora, in crescendo, l’esasperato don Gonzalo della gaddiana Cognizione del dolore, ombroso e prevenuto, insofferente e angustiato, che veste tutto di una luce negativa, come se la vita da sempre non avesse saputo riservargli altro che offese. Abbiamo a che fare, insomma, con manifestazioni gravi del male di vivere oggettivato da Montale negli Ossi di seppia: forme degenerate, patologiche, da affidare – si direbbe – alle cure della psicanalisi26. D’altronde, le teorie freudiane, benché in ritardo e fra molte comprensibili resistenze, hanno attecchito anche in campo letterario27, a partire, talvolta, dalla diretta esperienza terapeutica affrontata dagli autori, come nel caso di Giuseppe Berto, che significativamente intitola Il male oscuro (1964) il suo romanzo psicanalitico, o di Ottiero Ottieri, in opere quali Il pensiero perverso (1971), Il campo di concentrazione (1972) o Contessa (1975). Ma prima di loro già Saba aveva rivisitato la sua infanzia in chiave freudiana nelle poesie del Piccolo Berto (1931), mentre Svevo su una cornice psicanalitica aveva costruito l’intera Coscienza di Zeno. L’incidenza di Jung nell’universo mitico di Pavese e la centralità di Lacan nei grandi ingorghi simbolici e nel trattamento dei materiali verbali che caratterizzano la poesia di Zanzotto danno poi una misura significativa della fortuna incontrata nella letteratura italiana contemporanea anche dagli sviluppi più o meno ortodossi o notoriamente scismatici delle dottrine freudiane. Né si possono tralasciare Alberto Moravia, Mario Tobino, Guido Piovene o Cesare Viviani.
La psicanalisi di fatto gioca un ruolo notevole nella revisione novecentesca dell’idea di uomo. Se ne avverte l’influsso specialmente dove gli scrittori mettono a nudo le pulsioni primarie dell’individuo, le radici inconfessabili del desiderio, le spinte che si agitano negli strati profondi della psiche, le dinamiche conflittuali, i meccanismi di difesa, gli spostamenti, i sintomi nevrotici di compromesso, nonché le somatizzazioni. In questo senso, la psicanalisi contribuisce, in maniera non secondaria, a introdurre il tragico nel quotidiano.
Note
- 12 In LUIGI PIRANDELLO, Tutti i romanzi, I, Milano, Arnoldo Mondadori, 1973, p. 584.
- 13 Ivi, p. 580.
- 14 Ivi, pp. 580-581.
- 15 GIACOMO DEBENEDETTI, Il personaggio-uomo, Milano, Garzanti, 1988, p. 68.
- 16 Ibid.
- 17 Conclusione a cui giunge, com’è noto, studiando il morbo di Basedow. Cfr. ITALO SVEVO, La coscienza di Zeno, edizione critica a cura di BEATRICE STASI, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2008, p. 303.
- 18 In LUIGI PIRANDELLO, Tutti i romanzi, II, Milano, Arnoldo Mondadori, 1973, p. 820.
- 19 Cfr. GIORGIO BÀRBERI SQUAROTTI, La forma e la vita: il romanzo del Novecento, Milano, Mursia, 1987.
- 20 Cfr. in FEDERIGO TOZZI, Opere, Milano, Arnoldo Mondadori, 1987, p. 399.
- 21 Cfr. in PIER PAOLO PASOLINI, Romanzi e racconti, I, Milano, Arnoldo Mondadori, 1998, pp. 695-698.
- 22 In MONTALE, Tutte le poesie, cit., p. 276.
- 23 In PRIMO LEVI, Opere, I, Torino, Einaudi, 1997, p. 5.
- 24 In CALVINO, Romanzi e racconti, cit., pp. 497-498.
- 25 In DINO BUZZATI, Il Colombre e altri cinquanta racconti, Milano, Mondadori, 1966, pp. 381-449.
- 26 Per quel che concerne Gadda cfr. ELIO GIOANOLA, L’uomo dei topazi. Saggio psicanalitico su C.E. Gadda, Genova, Il Melangolo, 1977.
- 27 Cfr., oltre al classico MICHEL DAVID, La psicoanalisi nella cultura italiana, Torino, Boringhieri, 1966, CLAUDIO TOSCANI, La metastasi analitica, Milano, Effe Emme, 1978.
Giuseppe Langella: è professore ordinario di Letteratura italiana moderna e contemporanea presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e di Brescia. Dirige il Centro di ricerca "Letteratura e Cultura dell'Italia Unita" ed è coordinatore della Commissione didattica per Lettere moderne. È coautore, insieme a Pierantonio Frare, Paolo Gresti e Uberto Motta, della Letteratura italiana Amor mi mosse, che sarà pubblicata da Pearson Bruno Mondadori nel 2019.