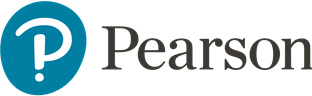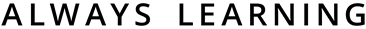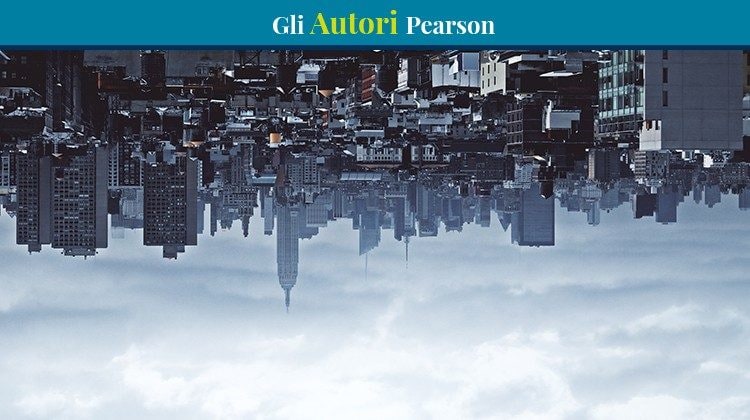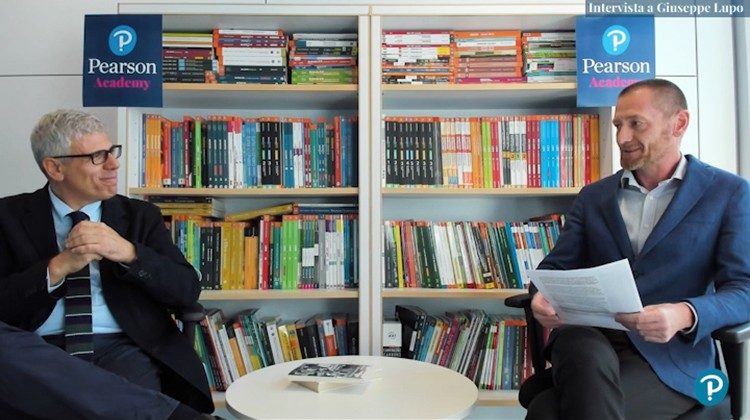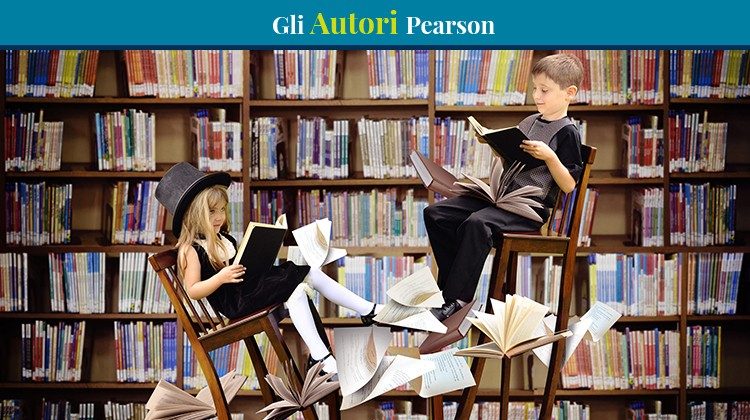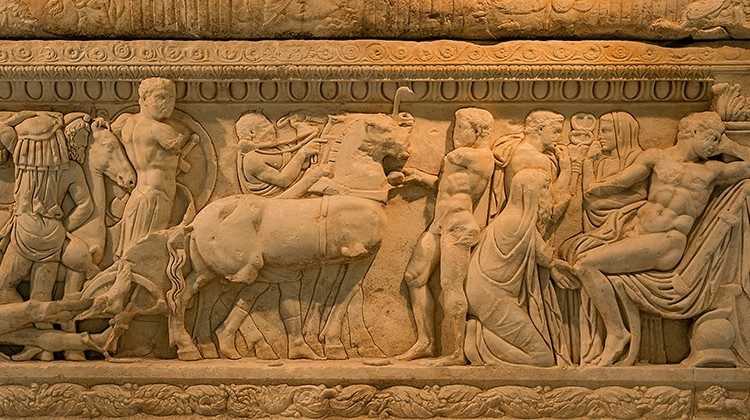
Il secolo degli ossimori

Strutture bipolari della visione novecentesca
APPROFONDIMENTI DISCIPLINARI
Il Novecento è il secolo che, in letteratura e non solo, ha stravolto tutti i paradigmi della tradizione precedente: ne sono un esempio la dissoluzione della distinzione tra generi letterari, l’accostamento di piani opposti, il superamento delle categorie di ordinario e straordinario, secondo l’idea che nessuno da vicino è normale, e il concetto del tragico quotidiano, per cui la violenza brutale irrompe nella vita di tutti i giorni. Per questo possiamo definire il Novecento come il secolo delle strutture ossimoriche.
di Giuseppe Langella
Il Novecento è stato preso, spesso, da una voglia matta di sparigliare le carte, d’intorbidare le acque, di mettere, per dirla con Luzi, tutto in questione1. L’imperativo categorico, per tutti: capovolgere, cambiare prospettiva. Simona Costa ha additato, al riguardo, due gesti davvero icastici e in qualche modo riassuntivi di questo atteggiamento2: il montaliano, epifanico, voltarsi indietro di Forse un mattino andando in un’aria di vetro3 e, più carnevalesco e bachtiniano ancora, l’Orlando calviniano del Castello dei destini incrociati, che chiude appeso a testa in giù la sua storia di pazzo per amore, con la lapidaria richiesta di essere lasciato così: «Ho fatto tutto il giro e ho capito. Il mondo si legge all’incontrario»4. Ma quel che è peggio, nella sua smania di originalità, per vincere a ogni costo l’angoscia dell’influenza5, il Novecento ha fatto saltare perfino il principio aristotelico di non contraddizione, mettendo insieme ciò che Orazio, convinto che un’opera d’arte dovesse essere semplice e una, avrebbe bollato come una combinazione mostruosa, frutto di una mente delirante. Si direbbe, anzi, che gli autori del Novecento abbiano assunto a proprio motto la potestas quidlibet audendi, il diritto cioè di osare a oltranza, che l’Ars poetica concedeva a denti stretti e con pronte e severe limitazioni6.
Sono abbastanza frequenti, negli autori novecenteschi, alcune caratteristiche aberrazioni ottiche, sempre complementari e di natura binaria: diplopie (vulgariter: vederci doppio), che prevedono la formazione di due distinte immagini dello stesso oggetto, o, al contrario, sovrimpressioni, per cui due diversi oggetti appaiono sovrapposti. Per un facile e immediato riscontro del primo disturbo, si potrebbero citare la scomposizione della figura nell’arte cubista o la cinematica dei corpi nelle tele futuriste, che producono effetti analoghi di sdoppiamento, o addirittura di moltiplicazione dell’immagine; ma, spostando il campo d’osservazione sul terreno letterario, con strumenti d’indagine appena più sofisticati, a voler applicare questa chiave a capolavori indiscussi del romanzo novecentesco come La coscienza di Zeno o Il fu Mattia Pascal o l’opera in generale di Pirandello, novelle e teatro compresi, si farebbero delle scoperte di non poco conto.
Quanto all’altro tipo di aberrazioni ottiche, non si creda che le sovrimpressioni siano una prerogativa del cinema o della fotografia: la letteratura del Novecento le ha praticate anzi in maniera assai meno episodica, facendone quasi la cifra della propria modernità di visione. Fuor di metafora: in molte opere del secolo scorso capita che gli opposti si tocchino, che quanto per interi millenni era stato rigorosamente separato all’improvviso si confonda. Nessuna teoria della letteratura basata sul principio della divisione dei generi e degli stili ha goduto di buona cittadinanza tra gli scrittori del Novecento, attratti, al contrario, da tutte le possibili liaisons dangereuses. Son venuti di moda i capi double face, buoni per tutte le stagioni, particolarmente adatti ai climi incerti e instabili di un mondo in crisi. Il Novecento è il secolo delle strutture ossimoriche.
1. Il riso amaro
Così è, per cominciare, del tragico e del comico, che non si spartiscono più le occasioni della vita secondo alterne vicende, ma si avviluppano intorno al medesimo avvenimento, in maniera inscindibile, come fratelli siamesi o erme bifronti. Dall’Umorismo (1908) pirandelliano al Palio dei buffi di Palazzeschi (1937), dalla Serena disperazione di Umberto Saba (1920) a L’è el dì di Mort, alegher! di Delio Tessa (1932), dall’Hilarotragoedia di Giorgio Manganelli (1964) all’Allegro con disperazione di Gianna Manzini (1965), il Novecento è il secolo del riso amaro7 o, per dirla con Giuseppe Ungaretti, dell’Allegria di naufragi (1919).
Il campo di applicazione dell’umorismo in Pirandello
L’interpretazione pirandelliana dell’umorismo come sentimento del contrario è troppo nota perché si debba qui richiamarla. Preme semmai ribadire, a margine, due concetti inerenti al nostro argomento; anzitutto il suo campo di applicazione. La visione umoristica può scattare solo a una condizione: che il soggetto rappresentato compia un atto intenzionale. Il presupposto è che esso provi dei sentimenti, nutra dei desideri, possieda una volontà. L’inerzia (quando non sia, beninteso, il frutto essa stessa di una scelta intenzionale) o l’azione istintiva non sono materia passibile di trattamento umoristico, perché rientrano nella sfera della natura, e la natura, per Pirandello, è quello che è e non potrebbe essere altrimenti che così, per obbedienza a una legge di necessità assoluta, di modo che non può essere in alcun modo giudicata, né derisa né compianta. Un paesaggio, insomma, dove non si veda la mano dell’uomo, non sarà mai umoristico. L’umorismo può scaturire solo in presenza di una volontà in atto, di un mondo psicologico che si traduce in un comportamento. A Pirandello, insomma, e con lui a molti autori del Novecento, interessano i risvolti problematici del reale, perché presentano un’ambiguità di fondo e non ammettono, quindi, un giudizio univoco.
La natura bipolare dell’umorismo
In secondo luogo va sottolineata la natura bipolare dell’umorismo, in cui la pietà si mescola allo scherno, rispetto a quella spontanea e a senso unico del comico, che conosce solo il riso a cuor leggero. Il riso amaro, appunto, davanti a «questa povera natura umana inferma di tante debolezze»8, è la risultante della visione umoristica, la reazione mista, bifronte, generata dal sovrapporsi del sentimento del contrario all’avvertimento del contrario. Peraltro, questa duplicità dipende dal fatto che nella concezione di un’opera umoristica entra in gioco la riflessione, cui Pirandello assegna anzi un ruolo essenziale. In altri termini, l’umorismo comporta uno «sdoppiamento nell’atto della concezione», una speciale «disposizione d’animo» da parte dell’autore9, che affianca al sentimento la riflessione. Oltre tutto, la riflessione funziona sempre da contrappunto rispetto al sentimento, si pone con esso in rapporto di negazione dialettica. Per un pensiero che nasce nell’animo dell’umorista, subito un altro sbuca fuori di segno opposto, contrario; ogni volta che egli sta per aderire a un sentimento, subentra immediatamente la riflessione, che «gli fa una smorfia e lo turba e lo sconcerta e lo indispettisce»10. Diviso, perciò, tra sentimento e riflessione, lo scrittore umorista «si trova ad esser sempre quasi fuori di chiave, ad essere a un tempo violino e contrabbasso»11.
Pirandello vuol dire, insomma, che l’opera umoristica viene composta, o piuttosto scomposta, dall’autore su due pentagrammi paralleli, che producono tra loro dissonanze e stridori, perché le note del secondo pentagramma, gravi dove le altre sono acute, meste dove le altre sono squillanti, malinconiche dove le altre sono allegre, formano rispetto a quelle del primo un continuo, irriverente, malizioso, controcanto.
Note
- 1 MARIO LUZI, Tutto in questione, Firenze, Vallecchi, 1965.
- 2 SIMONA COSTA, Gli antiromanzi, in Le forme del romanzo italiano e le letterature occidentali dal Sette al Novecento, a cura di SIMONA COSTA e MONICA VENTURINI, I, Pisa, Edizioni ETS, 2010, pp. 112-113.
- 3 EUGENIO MONTALE, Ossi di seppia, in Tutte le poesie, Milano, Arnoldo Mondadori, 1984, p. 42.
- 4 ITALO CALVINO, Romanzi e racconti, II, Milano, Arnoldo Mondadori, 1992, p. 532.
- 5 HAROLD BLOOM, The Anxiety of Influence. A Theory of Poetry, New York, Oxford University Press, 1973.
- 6 QUINTI HORATI FLACCI, Ars poetica, vv. 7-10, 23; in Opera, London, Oxford University Press, 1963.
- 7 Con la non trascurabile anticipazione del Giovanni Episcopo (1892) di D’Annunzio, segnalata da SIMONA COSTA nella sua relazione-quadro sul Sublime dal tragico di Alfieri all’umorismo di Pirandello, in Sublime e antisublime nella modernità. Atti del XIV Convegno Internazionale della MOD, a cura di MARINA PAINO e DARIO TOMASELLO, Pisa, Edizioni ETS, 2014, p. 40.
- 8 Ivi, p. 929.
- 9 Ivi, pp. 917, 919.
- 10 Ivi, p. 921.
- 11 Ibid.