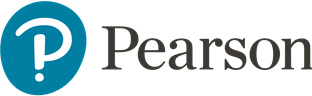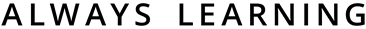Idee e immagini dell’Europa fra storia e letteratura

CULTURA STORICA
Un percorso storico-letterario sull’idea di Europa: dal mito delle origini, passando per Boccaccio e gli umanisti, Muratori e Voltaire, Defoe e Swift, fino alla Giovine Europa di Mazzini e al Novecento. Con una scelta di letture e di autori che nell’ultimo secolo hanno restituito, da diverse angolazioni, idee e immagini dell’Europa ben contestualizzate nel tempo storico in cui vissero e vivono. Schede di approfondimento dedicate a Valéry, Zweig, Canetti, Magris, Tuzzi.
Paolo Senna
All’origine, il mito. È infatti con il racconto della giovane Europa, figlia del re dei fenici rapita dal toro-Zeus, che ha origine la rappresentazione ideale del nostro continente. La storia della giovane Europa è però anche la storia dei suoi fratelli che, partiti in varie direzioni per cercarla, approdano su terre nuove o ignote, conoscendole e colonizzandole. L’idea che l’antichità si è fatta dell’Europa è intimamente legata al tema del “movimento”, all’incontro-scontro tra i popoli e le culture, caratteristica che l’Europa sembra portare in sé come una sorta di destino o di impronta nascosta nel DNA.
Boccaccio e gli umanisti
Si deve a Giovanni Boccaccio (1313-1375) nel Commento alla Divina Commedia la creazione del termine “europico” in relazione al mare Mediterraneo, contrapponendo le acque più vicine all’Europa a quelle invece adiacenti l’Africa: «e così come quello che verso Affrica si distende, chiamano Affricano, così questo, Europico, il quale si stende infino all’isola di Creti, dove dicemmo terminarsi il mare Egeo». Questo conio non è di poco rilievo: Boccaccio in quel punto sta commentando i vv. 94 ss. del XIV canto della Commedia («in mezzo al mar siede un paese guasto…») e discorre della divisione del mondo «in questo nostro emisperio superiore» che secondo gli antichi era formato da «tre parti […] Asia, Europa e Affrica». «Europico» è dunque aggettivo che identifica ma anche che si contrappone alla restante parte del mondo conosciuto.
È poi con Enea Silvio Piccolomini (1405-1464), papa con il nome di Pio II e celebre umanista, che assistiamo all’entrata in vigore del vocabolo europaeus (“europeo”). Anche in questo caso si evidenzia una contrapposizione, o meglio, una precisazione. L’Europa a quel tempo coincideva con la christianitas, ossia l’insieme delle terre unite dall’unica fede, concetto che non aveva solo valore religioso, ma determinava anche una omogeneità di cultura, una unità ideale in grado di andare oltre l’unificazione politica. L’adozione del termine europaeus mirava a restituire piena cittadinanza al mondo classico ritenuto autorevole fonte di valori universali e, al contempo, intendeva sottolineare l’idea di un’Europa elitaria, colta, formata e diretta da umanisti dediti alla riscoperta della cultura classica; un’Europa il cui asse risulta dunque decisamente inclinato verso occidente. Concetti simili sono espressi anche da altri esponenti di primo piano della cultura umanistica che vagheggiarono una vera e propria respublica litteraria europea, come Erasmo da Rotterdam ed Ermolao Barbaro e l’editore Aldo Manuzio.
Il Settecento
Tra evoluzione e continuità con i valori dell’elaborazione umanistica dell’idea di Europa, all’inizio del Settecento Ludovico Antonio Muratori (1672-1750) in I primi disegni della repubblica letteraria d’Italia (1703), descrive un’Europa di nazioni, le cui letterature rappresentano il frutto delle varie repubbliche letterarie nazionali. Per realizzare tale repubblica nazionale, Muratori elabora il progetto di dar vita a un’accademia in grado di radunare le migliori menti della cultura italiana al fine di favorirne il progresso letterario. In coerenza con Muratori, Voltaire (1694-1778) nel Secolo di Luigi XIV concepisce l’idea di una sola repubblica divisa in più stati:
«L’Europa supera in ogni campo le altre parti del mondo. […] Già da molto tempo si poteva considerare l’Europa cristiana (ad eccezione della Russia) come una specie di grande repubblica divisa in più Stati, gli uni monarchici, gli altri misti, alcuni aristocratici, altri popolari: ma tutti press’a poco simili, avendo tutti uno stesso fondo di religione, sebbene diviso in più sètte; e tutti hanno gli stessi princìpi di diritto pubblico e di politica, sconosciuti nelle altre parti del mondo.» (Voltaire, Prefazione a Il secolo di Luigi XIV, trad. di U. Morra, Einaudi, Torino 1951).
Nel corso del Settecento, due opere letterarie incarnano un’idea di Europa significativa, ognuna con qualità e tratti specifici. Si tratta di due celeberrimi racconti di viaggio e di fantasia: il Robinson Crusoe di Daniel Defoe (1660-1731) e I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift (1667-1745). Pur nella evidente diversità delle narrazioni e degli stili, entrambi i protagonisti attuano (o subiscono) un percorso che dal “centro” (l’Europa, in particolare l’Inghilterra) si dirige verso la “periferia” (terre selvagge, sconosciute o immaginarie), per poi fare ritorno al punto di partenza. L’idea di Europa trova una sua definizione nel momento in cui il protagonista si trova di fronte a un mondo “altro”, percepito lontano e distante dalle proprie categorie culturali.
L’enorme successo del Robinson Crusoe spinse Defoe a scrivere subito le Ulteriori avventure di Robinson Crusoe (entrambi del 1719) che si collocano in esatta continuità al primo romanzo. In questo secondo libro sono narrati altri viaggi, peripezie e battaglie e il ritorno in patria dopo un percorso attraverso la Cina e la Russia. Partito dalla città siberiana di Tobol’sk Robinson descrive l’ingresso in Europa dalle steppe orientali, oltre quella ideale linea che, tracciata dal Mar Caspio al Mar Nero, la divide dall’Asia. Lungo questo percorso però Robinson non riscontra alcuna differenza tra le usanze dei popoli al di qua e al di là dell’invisibile confine:
«Eravamo appena entrati in Europa, avendo superato il fiume Kama, che in queste parti è il confine fra l’Europa e l’Asia, e la prima città sul lato europeo si chiama Solikamsk, che è come dire la Grande città sul fiume Kama; e qui ci aspettavamo di vedere alcuni mutamenti palesi nella popolazione, nei suoi costumi, modo di vestire, religione, occupazioni; ma ci sbagliavamo, perché siccome avevamo un vasto deserto da attraversare, che, a quanto si dice, è lungo quasi settecento miglia in alcuni punti, ma non più di duecento dove lo attraversammo noi, così, finché non superammo quell’orribile paese, osservammo pochissime differenze tra di esso e la Tartaria mongolica: la gente per lo più pagana e poco migliore dei selvaggi d’America, le case e le città pieni di idoli e il modo di vivere assolutamente barbaro, tranne nelle suddette città e nei villaggi adiacenti, dove sono cristiani, come si proclamano, di rito greco, ma hanno una religione mista a tanti residui di superstizione che in alcuni luoghi è difficile distinguerla dalla pura e semplice stregoneria e magia.» (D. Defoe, Le avventure di Robinson Crusoe, seguito da: Le ulteriori avventure e Serie riflessioni, Einaudi, Torino 1998).
L’Europa coincide dunque davvero con i suoi confini? Oppure l’Europa è un insieme eterogeneo di popoli che, da sempre, hanno abitudini anche estremamente differenti ma che si sentono “europei”?
Un comune denominatore dei popoli europei è ironicamente individuato nei Viaggi di Gulliver (1726), quando il protagonista che si trova nel paese degli Houyhnhnm viene sollecitato ad informare il suo padrone su ciò che accade in Inghilterra e in Europa:
«E io gli dispiegai innanzi, come meglio potei, l’intiero stato delle cose in Europa, parlando di commerci e di industrie, di arti e di scienza; e le risposte a tutte le domande ch’egli poneva, sollevate dai più vari argomenti, erano un’inesauribile riserva per altre conversazioni. […] Obbedendo alle sollecitazioni di Sua Grazia, gli feci un resoconto della Rivoluzione sotto il principe di Orange, nonché della guerra con la Francia iniziata dal detto principe e continuata dal suo successore al trono, l’attuale Regina: guerra in cui s’erano immischiate le maggiori potenze della Cristianità, e che ancora era in corso. […] Mi domandò quali fossero le usuali cause o i moventi che inducevano un paese a far guerra contro un altro. Risposi ch’erano innumerevoli, e avrei potuto indicargliene soltanto alcuni tra i principali. Talora è l’ambizione dei principi, a cui non sembra mai d’avere terra o sudditi da governare. Talaltra è la corruttela dei ministri, che spingono il loro padrone in una guerra per soffocare o stornare le proteste contro la loro malvagia amministrazione. Le divergenze d’opinione sono già costate molti milioni di vite. […] Ciò che m’hai detto al riguardo della guerra, fece notare il mio padrone, invero rivela mirabilmente quali siano gli effetti della Ragione che voi pretendete di possedere.» (J. Swift, I viaggi di Gulliver, Se, Milano 2014).
Nell’affresco ferocemente satirico posto in atto da Swift l’idea di Europa è strettamente connessa alle abili manovre poste in atto dalla Ragione per giustificare le azioni di guerra, prodotte nella totalità dei casi enumerati dall’autore da cause futili o coperte da giustificazioni bizzarre.
Da Mazzini al Novecento
Nell’Ottocento l’idea di Europa si scontra con i moti rivoluzionari che mirano alla esaltazione delle identità nazionali. Il pensiero di Giuseppe Mazzini (1805-1872) celebra il concetto di patria, ma essa viene posta in relazione con il valore più globale dell’umanità, in vista dell’aspirazione alla libertà di un continente visto non più come Europa dei prìncipi, ma come Europa dei popoli: una Giovine Europa dunque intesa come «associazione di tutti coloro i quali, credendo in un avvenire di libertà, d’eguaglianza, di fratellanza per gli uomini quanti sono, vogliono consecrare i loro pensieri e le opere loro a fondare questo avvenire. […] Costituire l’Umanità in guisa ch’essa possa avvicinarsi il più rapidamente possibile, per un continuo progresso, alla scoperta ed all’applicazione della Legge che deve governarla: tale è la missione della Giovine Europa». (G. Mazzini, Istruzione generale per gli iniziatori, in Scritti. Politica ed economia, vol. 1, Sonzogno, Milano [s.d.]).
Infine, nel Novecento l’idea di Europa si lega indissolubilmente alle grandi tragedie che hanno attraversato il secolo, dalle guerre all’Olocausto alla divisione in due blocchi contrapposti, ma anche al desiderio di ricostruzione, di rinascita e di libertà e poi di unità che l’Europa ha inteso e ancora intende realizzare.
Di seguito proponiamo, attraverso schede di approfondimento, una scelta di letture e di autori che, da diverse angolazioni, hanno proposto, elaborato e restituito nei loro libri un’idea o un’immagine dell’Europa che riflette il tempo storico in cui vissero e vivono.
Paul Valéry
La crisi del pensiero, 1919
In Opere scelte, Mondadori, Milano 2014
Paul Valéry (1871-1945) è stato un importante scrittore francese. Dopo l’esordio giovanile come poeta simbolista e l’ingresso nella cerchia di Mallarmé, visse nel 1892 una profonda crisi esistenziale che lo portò ad allontanarsi dalla scrittura poetica. Proprio in quel periodo iniziò la redazione dei Cahiers, opera che riprese ed estese lungo tutto l’arco della vita. Ritornò alla poesia nel 1917, diventando una sorta di poeta ufficiale della Francia ed entrando a far parte dell’Académie française. Caduto in disgrazia durante il governo collaborazionista della Francia occupata, morì nel 1945, appena terminata la guerra.
La crisi del pensiero venne pubblicata nel 1919, dopo la fine della Grande guerra e divenne subito un testo ampiamente commentato dai letterati e dagli uomini di cultura del tempo. In particolare la riflessione sul popolo tedesco – le cui grandi virtù «hanno generato più mali di quanti vizi abbia mai prodotto l’ozio » – fu particolarmente sentita come attuale dopo il secondo conflitto mondiale, quando il nazismo si era macchiato di genocidi e stermini su vasta scala. L’idea di Europa su cui il poeta riflette è quella della fine di una civiltà, dell’uomo occidentale che, posto come alla fine del tempo, medita sulla vita e la morte delle verità:
«Ormai noi civiltà sappiamo di essere mortali. Avevamo sentito parlare di mondi interamente scomparsi, di imperi colati a picco con tutti i loro uomini e tutte le loro macchine, scesi nel fondo inesplorabile dei secoli coi loro dèi e le loro leggi, le loro accademie e le loro scienze pure e applicate, con le loro grammatiche, i loro dizionari, i loro classici, i loro romantici, i loro simbolisti, i loro critici e i critici dei loro critici. Ben sapevamo che tutta la terra visibile è fatta di ceneri e che la cenere ha pur un qualche significato. […] Ora, su un’immensa terrazza di Elsinore, che va da Basilea a Colonia, si spinge fino alle sabbie di Newport, alle paludi della Somme, ai calcari della Champagne e ai graniti dell’Alsazia, l’Amleto europeo contempla milioni di spettri. Ma è un Amleto intellettuale. Medita sulla vita e la morte delle verità. I suoi fantasmi sono tutti gli oggetti delle nostre controversie, i suoi rimorsi sono tutti i titoli della nostra gloria; è oppresso dal peso delle scoperte, delle conoscenze, incapace di rimettersi a questa attività illimitata. Pensa alla noia di ricominciare il passato, alla follia di voler sempre rinnovare.»
Stefan Zweig
Il mondo di ieri. Ricordi di un europeo, 1942
Mondadori, Milano 1946
Stefan Zweig (1881-1942) nacque a Vienna da un’agiata famiglia ebraica. Pur non avendo combattuto nella Prima Guerra Mondiale, visse l’avvenimento in maniera estremamente traumatica poiché esso segnò il dissolversi dell’Impero austroungarico e di quell’idea condivisa e familiare dell’Europa comune a lui e a molti altri scrittori della sua epoca. Al termine del conflitto era divenuto ormai uno scrittore affermato, in contatto con i maggiori intellettuali del tempo. Con la salita al potere di Hitler in Germania, le sue opere, così come quelle di molti altri scrittori ebrei, furono arse nei tristemente celebri roghi nazisti. Nel 1934 Zweig lasciò l’Austria e si stabilì in Gran Bretagna, ottenendo la cittadinanza britannica nel 1938, al momento dell’annessione (Anschluss) dell’Austria da parte della Germania nazista. Allo scoppio della Seconda guerra mondiale abbandonò definitivamente l’Europa, stabilendosi prima a New York e poi in Brasile, dove nel 1942 si tolse la vita insieme alla seconda moglie, di fronte all’immensa tragedia che stavano vivendo la “sua” Europa e il resto del mondo in quegli anni.
Il mondo di ieri. Ricordi di un europeo, scritto durante l’esilio brasiliano (1939-1941) che coincise con gli ultimi anni di vita dell’autore, venne pubblicato postumo nel 1942 a Stoccolma. Si tratta di un romanzo parzialmente autobiografico, che prende le mosse dai ricordi di gioventù di Zweig. Il romanzo descrive la formazione del protagonista nella fiorente Vienna di fine Ottocento, quindi la Belle Époque, periodo apparentemente roseo, ma colmo di contraddizioni, e l’escalation di accadimenti che avrebbero portato alla Grande guerra. L’Europa individuata dall’autore coincide con il tramonto della felix Austria. Le vicende personali di Zweig sono sempre fortemente intrecciate con gli avvenimenti storici e culturali narrati. Il romanzo si conclude con l’invasione della Polonia da parte della Germania il 1° settembre 1939:
«Mai ho tanto amata la nostra vecchia terra come in quegli ultimi anni prima della guerra, mai ho tanto sperato nell’Europa, mai ho tanto creduto nel suo futuro come in quegli anni in cui ci sembrava di assistere ad una nuova aurora. Era invece già l’igneo riflesso dell’enorme incendio che si avvicinava. […] La più intima missione, quella cui per quarant’anni avevo dedicata ogni energia del mio convincimento, la pacifica federazione dell’Europa, era andata in rovina; quello che io avevo temuto più che la mia stessa morte, la guerra di tutti contro tutti, era ormai scatenata per la seconda volta.»
Elias Canetti
La lingua salvata. Storia di una giovinezza, 1977
Adelphi, Milano 1995
Elias Canetti (1905-1994) nacque in Bulgaria da una famiglia ebraica, le cui origini si perdevano tra la Spagna e l’Italia. Nel 1911 i Canetti si trasferirono in Inghilterra per motivi di lavoro del padre, commerciante. Dopo la sua morte avvenuta nel 1912, la madre, donna colta e dalla mentalità aperta ma sofferente di turbe depressive, si trovò a dover provvedere alla famiglia e i trasferimenti di quegli anni attraverso l’Europa furono numerosi. Tra il 1924 e il 1938 Canetti visse quasi ininterrottamente a Vienna, dove si integrò nella cerchia culturale cosmopolita della capitale. A seguito dell’annessione dell’Austria da parte della Germania nazista si trasferì prima a Parigi e poi a Londra, acquisendo successivamente la cittadinanza britannica. Vincitore del Premio Nobel per la Letteratura nel 1981, trascorse gli ultimi anni della sua esistenza a Zurigo, dove morì nel 1994.
La lingua salvata. Storia di una giovinezza, edito nel 1977, è la prima parte della trilogia che costituisce l’autobiografia di Canetti. Le vicende narrate nel libro sono suddivise in quattro grandi sezioni, ambientate in luoghi e periodi differenti dell’infanzia e della giovinezza. La prima sezione, intitolata Rustchuk (l’odierna Ruse, in Bulgaria) narra gli avvenimenti dalla nascita dello scrittore nel 1905 al trasferimento nel 1911 a Manchester, che costituisce la seconda sezione, dedicata agli avvenimenti tra il 1911 e il 1913. La terza sezione è dedicata al primo soggiorno viennese, tra il 1913 e il 1916; infine l’ultima al periodo trascorso a Zurigo tra il 1916 e il 1921 (a sua volta suddivisa in due sottosezioni, dedicate a due località differenti della città svizzera).
L’Europa che emerge da questo romanzo è filtrata dalle vicende personali di Canetti, è quindi un’“Europa dell’anima”, un’“Europa delle lingue” parlate nella sua infanzia da lui e dai suoi cari: il giudeo-spagnolo (uno spagnolo arcaico parlato dagli ebrei sefarditi, che dovettero lasciare la Spagna in seguito all’espulsione nel 1492), utilizzato dai genitori di Canetti per rivolgersi a lui e ai suoi fratelli, nonché agli altri membri della cerchia familiare; il tedesco, utilizzato dai genitori per conversare tra di loro, e da essi considerato la lingua della cultura; e il bulgaro, utilizzato da coloro che lavoravano in casa Canetti e dalle altre persone con cui quotidianamente si aveva a che fare, essendo la famiglia residente inizialmente in Bulgaria. In seguito, il piccolo Elias si trova ad aver a che fare con l’inglese, a causa del trasferimento della famiglia a Manchester, e poi nuovamente con il tedesco a Vienna e a Zurigo. I genitori di Canetti, con le loro aspirazioni culturali e con il desiderio di miglioramento sociale, dischiudono al piccolo Elias un mondo nuovo, che si distacca dalla tradizione familiare della pratica commerciale. I continui trasferimenti nei tentativi di migliorarsi e la tensione verso l’Occidente (dal quale i due rami familiari erano giunti, rispettivamente dalla Spagna e dall’Italia), costituiscono al tempo stesso un’evoluzione e un ritorno alle origini, chiudendo una sorta di cerchio ideale.
«Tutti gli eventi di quei miei primi anni si svolsero dunque in spagnolo o in bulgaro. In seguito mi si sono in gran parte tradotti in tedesco. Solo eventi particolarmente drammatici, delitti e morti, per intenderci, nonché i più grandi spaventi della mia infanzia, mi sono rimasti impressi nella loro fraseologia spagnola, ma in modo estremamente preciso e indistruttibile. Tutto il resto, vale a dire il più, e specialmente tutto ciò che era bulgaro, come appunto le favole, me le porto in testa in tedesco. […] Mi regalarono un puzzle della carta geografica dell’Europa, dipinta a colori su legno e suddivisa in pezzi che corrispondevano ai diversi Paesi. Si rovesciavano tutti i pezzi in mucchio e poi con la velocità del fulmine si rimetteva insieme l’Europa. Ogni Paese aveva la sua forma con cui le mie dita prendevano familiarità e un giorno sorpresi mio padre dichiarando: «Posso farlo anche a occhi chiusi!». «Impossibile!» replicò lui. Io chiusi ben bene gli occhi e affidandomi unicamente al tatto ricomposi l’Europa.»
Claudio Magris
Danubio, 1986
Garzanti, Milano 1986
Claudio Magris (1939) è uno scrittore triestino, docente universitario ed esperto germanista. Vincitore del premio Bagutta con Danubio, pubblicato nel 1986, e di numerosi altri premi con le opere successive, ha dedicato gran parte dei suoi studi alla letteratura mitteleuropea.
Danubio è un’opera composta da una serie di racconti, scaturiti da un viaggio compiuto dall’autore che, insieme ad alcuni amici, ha attraversato l’Europa centro-orientale seguendo il corso del fiume, dalla misteriosa e ancora oggi contestata sorgente, fino alla sua foce. Il Danubio è il secondo fiume europeo, dopo il Volga, ed il più lungo canale navigabile dell’Unione Europea. Nasce in Germania e attraversa altri nove Stati (Austria, Slovacchia, Ungheria, Croazia, Serbia, Bulgaria, Romania, Moldavia e Ucraina), per poi gettarsi nel Mar Nero. Grazie ai suoi molteplici affluenti e rami, il suo bacino idrografico si estende però fino a raggiungere altri nove paesi: Italia, Polonia, Svizzera, Repubblica Ceca, Slovenia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Repubblica di Macedonia e Albania. Va ricordato che nel momento in cui Magris compì questo viaggio, alla metà degli anni Ottanta, la “cortina di ferro” non era ancora caduta ed esisteva dunque una netta distinzione tra Europa dell’ovest, libera e democratica, ed Europa dell’est, governata da regimi socialisti e comunisti. Anche i confini (e gli stessi nomi) degli stati non erano quelli attuali.
Per il suo volume, Magris si riallaccia idealmente al concetto tradizionale, caro a molti scrittori, di grand tour attraverso l’Europa, ma il cliché letterario classico viene qui, per molti versi, stravolto e ribaltato. Proprio perché attraversa molte nazioni, il Danubio è un fiume dagli innumerevoli nomi: in aggiunta al tedesco Donau (che, si badi, è un sostantivo femminile), ci sono l’ungherese Duna, il rumeno Dunărea, solo per citarne alcuni, oltre naturalmente al latino Dānubius o Dānuvius. Ciò rispecchia molto bene l’idea del fiume nel quale non ci si può bagnare due volte, secondo quanto affermava il filosofo Eraclito. Alla mutevolezza del fiume corrisponde una variabilità nello stile del racconto, che non è mai uguale a se stesso, proprio come il corso d’acqua, ora un semplice e placido ruscello, ora un torrente in piena che rompe gli argini, ora un maestoso fiume che attraversa molte famose città europee, capitali e non.
Il Danubio è stato testimone, fin dalla notte dei tempi, di cruciali eventi storici che hanno cambiato il corso della storia e il volto dell’Europa: ha visto i latini cercare di contenere e respingere i “barbari” nelle loro terre, per poi soccombere e mischiarsi con essi; ha visto i turchi respinti nel 1683 alle porte di Vienna dopo un lungo assedio posto alla città; ha assistito a molte delle grandi e cruente battaglie delle due guerre mondiali. L’idea di Europa che deriva da questo romanzo è quella delle molte identità attraversate, unite (e divise) da un unico fiume. Magris ci racconta aneddoti di ciascuna località visitata e ci porta sulle tracce delle personalità importanti che vi sono nate o che le hanno rese celebri. Con la medesima capacità di interessare il lettore riesce a parlare del grande filosofo, così come dello sconosciuto contadino o dell’anonimo negoziante col quale si ferma a discorrere o a chiedere informazioni.
«Per il contadino del tardo medioevo, che non poteva guardare più in là del campo che arava, l’idea stessa del Limes, del Vallo che doveva segnare fino al Mar Nero i confini dell’impero romano, era qualcosa d’impensabile e di sovrumano, che trascendeva con l’idea la tangibile immediatezza quotidiana e doveva apparire quale opera di forze misteriose. […] Con gli anni, i decenni e i secoli mutano gli statuti delle città e le cifre delle nazionalità delle religioni; il crogiolo non cessa di ribollire, amalgamare, fondere, bruciare, consumare.»
Hans Tuzzi
Il Trio dell’Arciduca, 2014
Bollati Boringhieri, Torino 2014
Hans Tuzzi è lo pseudonimo col quale Adriano Bon (1952) consulente editoriale, docente, saggista e bibliofilo, ha pubblicato nel corso degli anni diversi saggi e romanzi gialli. Il nom de plume è stato scelto con evidente riferimento a L’uomo senza qualità di Robert Musil e la vera identità dell’autore è stata svelata solo dopo alcuni anni dalla pubblicazione dei suo primi gialli.
Il Trio dell’Arciduca è un giallo storico ambientato nel 1914, a pochi giorni dall’attentato di Sarajevo che costò la vita all’arciduca ereditario d’Austria Francesco Ferdinando ed è tradizionalmente considerato il casus belli della Prima Guerra Mondiale. Il romanzo è stato pubblicato nel 2014, in occasione della ricorrenza del centenario dell’inizio della Grande Guerra. Neron Vukcic è un giovane e promettente agente segreto montenegrino, al servizio dell’Impero austroungarico, che si ritrova ad indagare su un omicidio apparentemente banale, quello di un mercante levantino trovato morto nel molo di Trieste, città a quei tempi sotto il dominio austriaco. Fra Trieste, Costantinopoli e i Balcani si snoda un romanzo ricco di intrighi, nazionalità in rivolta e servizi segreti delle grandi potenze che cospirano nell’ombra. Ci troviamo ad un passo dalla “fine del mondo” fino a quel momento conosciuto, il declino della Belle Époque e l’inizio del tramonto dei tre grandi Imperi ormai agonizzanti, austroungarico, russo e turco, che scompariranno nel giro di pochi anni.
Nel romanzo assistiamo alla meticolosa descrizione dell’Impero austroungarico visto come un crogiolo di nazionalità, a quella data ormai sul punto di esplodere. Tuzzi, nelle parole dei suoi personaggi, fa emergere diversi livelli di “Europa” all’interno dell’Impero austroungarico: quella dei dominatori austriaci, che avevano sottomesso molti popoli con il diritto e con la lingua e - al di sotto di essi - slavi, ungheresi e italiani. Con grande arguzia Hans Tuzzi delinea un interessante personaggio, ispirato al celeberrimo investigatore Nero Wolfe, uscito dalla penna dello scrittore statunitense Rex Stout. Nero Wolfe era appunto di origine montenegrina e Tuzzi immagina, come in una sorta di prequel dei romanzi di Stout, le vicende accadute al giovane Wolfe in Europa prima di emigrare negli Stati Uniti e di “americanizzare” il proprio nome.
L’intrigante personaggio di Neron Vukcic ritornerà con un’altra indagine in un secondo romanzo, Il sesto faraone, pubblicato nel 2016.
«Neron Vukcic stava pensando che la convivenza, a pochi metri di distanza, di una chiesa, una moschea e una sinagoga costituiva un notevole credito per quello stanco Impero a due teste. […] La guerra. E si stava già mettendo in moto la macchina delle alleanze. No, non sarebbe stata una guerra balcanica, quella. Una guerra europea? E se anche? Lui era suddito imperialregio, ma la sua patria era il Montenegro.»
Bibliografia e approfondimenti
- E.R. Curtius, Letteratura europea, in Letteratura europea e medioevo latino, La Nuova Italia, Firenze 1992
- F. Moretti, La letteratura europea, Einaudi, Torino 1993 (Storia d’Europa, I: L’Europa oggi)
- A. Gnisci, Noialtri europei, Bulzoni, Roma 1994 (il cap. “L’Europa nella parola letteraria”)
- F. Sinopoli, Il mito della letteratura europea, Meltemi, Roma 1999
- Idee e ideali dell’Europa dalle origini ai nostri giorni, a cura di F. Pozzoli, Bompiani, Milano 1999
- F. Chabod, Idea d’Europa e civiltà moderna. Sette saggi inediti, a cura di M. Platania, Carocci, Roma 2010
- L’idea di Europa, a cura di C. de Luzenberger e M.L. Pelosi, Loffredo, Napoli 2011
Testi online
- Voce “Europa, idea di” in Dizionario di Storia Treccani
- L. Bigliocca, Radici storico filosofiche dell'Europa unita
- Jonathan Sisco, Un’idea di Europa