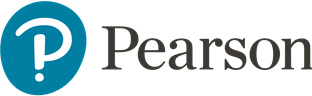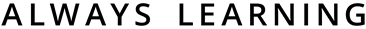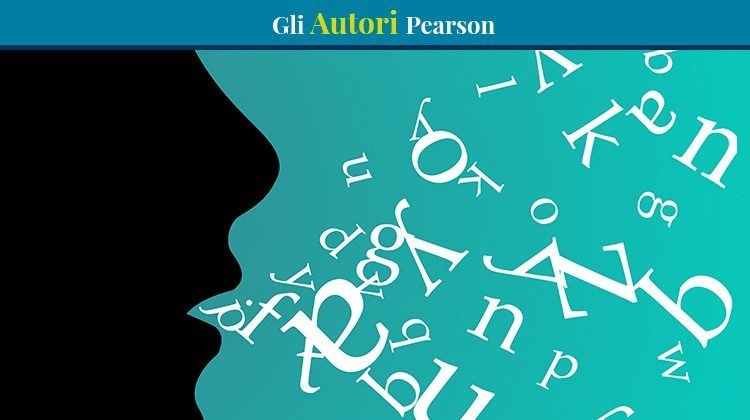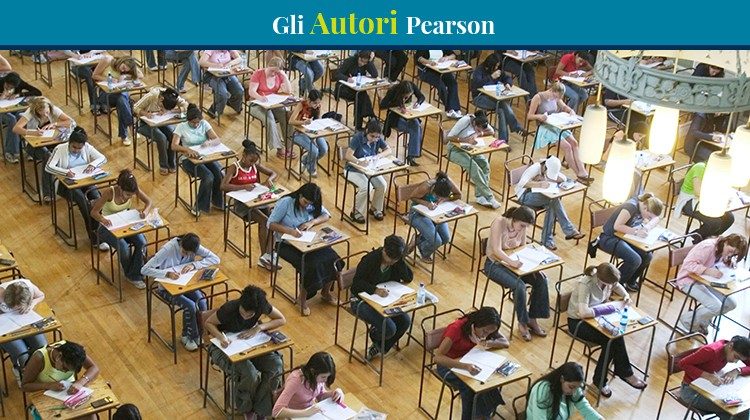
I “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” nel colloquio dell’Esame di Stato

L’esperienza dei candidati nella relazione della prova finale
APPROFONDIMENTI DISCIPLINARI
Nel nuovo Esame di Stato parte del colloquio sarà dedicata ai “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”. L’esperienza fatta dal candidato verrà esposta in una relazione e/o un elaborato multimediale. Cerchiamo di capire in che modo.
di Bianca Barattelli
Nelle travagliate vicende del nuovo Esame di Stato, il ruolo dell’ex Alternanza scuola-lavoro è stato uno dei punti più controversi: in un primo momento sembrava che se ne fosse persa ogni traccia, poi invece ne è stato recuperato lo spirito all’interno dei cosiddetti “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (d’ora in poi: PCTO) e si è deciso di prevedere uno spazio durante il colloquio all’interno del quale lo studente espone «mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento [...]» e, «oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma» (art. 19, O.M. 205 dell’11.3.2019).
Perché includere i PCTO nel colloquio d’Esame?
Elaborare e presentare una relazione è di per sé un’attività che presuppone ed esercita molte delle competenze acquisite dagli studenti durante il percorso scolastico, e che – nel momento in cui riguarda la propria esperienza anziché contenuti di studio – permette di esprimere giudizi autonomi e consapevoli. L’inclusione dei PCTO nel colloquio dell’Esame di Stato può quindi essere un momento assai qualificante per saggiare la formazione trasversale accanto all’acquisizione di competenze e contenuti disciplinari. È evidente che gli studenti dovranno evitare di enumerare semplicemente le attività svolte e di dare giudizi generici: il focus dev’essere l’apporto che i PCTO hanno dato alla loro formazione complessiva, integrandosi con le competenze acquisite attraverso lo studio, e il ruolo che potranno avere nelle loro scelte lavorative future.
Negli anni passati, quando si doveva trattare in prospettiva pluridisciplinare un tema a piacere, l’esposizione del percorso si riduceva spesso a una semplice lista di contenuti e collegamenti copiati e incollati dal web; visto che invece ogni esperienza complessiva di PCTO è personale, basterebbe questo a farla salutare come una provvidenziale boccata d’aria pura e un’occasione concreta per dimostrare spirito critico, capacità dialettica e consapevolezza. Inoltre, in questo momento dell’esame non entra in gioco nessuna disciplina specifica: ci si può quindi davvero concentrare sulla consapevolezza che i ragazzi hanno di sé, sul loro spirito critico e su come riescano a rapportarsi con la commissione.
Uno sguardo sul mondo del lavoro
Superata “l’emergenza 2019”, sarà più facile entrare nell’ottica che discutere dei PCTO nel colloquio dell’esame di Stato può essere un’ottima opportunità per far sentire gli studenti protagonisti del proprio esame come “giovani adulti” e far loro percepire, nella sua completezza e importanza, il momento di passaggio dalla scuola all’università e al mondo del lavoro.
La relazione va preparata sui tempi lunghi, nell’arco dell’intero triennio, attraverso la raccolta sistematica dei materiali relativi ai PCTO, e richiede una riflessione e una consapevolezza da raggiungere anche attraverso l’aiuto degli insegnanti e dei tutor aziendali.
I PCTO dovrebbero essere progettati e gestiti da tutto il Consiglio di classe e partire da una riflessione sul profilo offerto dall’indirizzo di studi scelto, per il quale forniscono materiale ampio e dettagliato il Piano dell’offerta formativa e gli altri documenti pubblicati di solito sul sito web della scuola nonché il Supplemento Europass al Certificato.
Per un’apertura invece sulle scelte universitarie e sugli sbocchi professionali può tornare utile il sito del consorzio universitario Almalaurea; informazioni sul mercato del lavoro e “borsa” delle qualifiche e professioni più richieste si trovano sul sito di Unioncamere.
Il concetto di deontologia professionale e la dimensione della Cittadinanza
Non andrebbe inoltre trascurata, all’interno dei PCTO, l’introduzione al concetto di deontologia professionale, da trattare quando possibile con gli insegnanti di filosofia (legandolo all’etica) o comunque da approfondire come dimensione fondamentale della vita lavorativa. Inutile poi ricordare che sul lavoro si può riflettere anche partendo dai contenuti disciplinari: dal negotium latino allo spirito del capitalismo alla rappresentazione dei mestieri nell’arte ai vari “tipi” e ambienti letterari (l’impiegato, il proletario, la fabbrica nel corso dei secoli) alla responsabilità dello scienziato.
Inoltre il complesso iter dei PCTO e la loro presentazione al colloquio dell’esame finale dovrebbero portare a confrontarsi con il lavoro come dimensione fondante della cittadinanza (vedi l’art. 1 della Costituzione), mettendo gli studenti in condizione di parlare e scrivere di sé basandosi su esperienze dirette e formulando giudizi argomentati anziché affidandosi alle semplici impressioni. Un obiettivo, e si spera un risultato, tutt’altro che trascurabile.
Come deve essere la relazione?
Il documento ministeriale specifica che l’esperienza di lavoro dovrà essere presentata attraverso una «breve relazione», quindi sarebbe opportuno evitare lunghe dissertazioni in “scolastichese”, ma puntare su una scrittura concisa ed efficace come quella richiesta nel mondo del lavoro. Alla relazione può essere affiancato un elaborato multimediale: fondamentale chiarire agli studenti che il supporto di slide, immagini, video ecc. non serve a mostrare l’abilità nell’uso delle tecnologie ma la capacità di usarle come supporto a un lavoro che nella sostanza resta pur sempre affidato alla parola. La presentazione orale, inoltre, non è certo la lettura della relazione: scritto e parlato hanno regole diverse, e su questo sarà opportuno affiancare alle indicazioni teoriche qualche esercizio in classe almeno nella parte finale dell’anno.
Diamo di seguito alcune indicazioni operative.
La lunghezza
In assenza di indicazioni puntuali, sarà bene affidarsi al buon senso:
• la “breve” relazione non dovrebbe superare le 3-4 cartelle (quindi le 10-12.000 battute, spazi compresi);
• la durata dell’esposizione dovrebbe essere contenuta in una decina di minuti, per lasciare uno spazio significativo anche alla discussione (ma su questo la commissione dovrà dare indicazioni precise);
• se si prevedono le slide, calcolarne al massimo una decina compresa quella di apertura e quella finale di chiusura e ringraziamento.
Gli aspetti formali
La presentazione dei PCTO non può certo avere una veste approssimativa: per essere adeguatamente professionale deve rispondere a requisiti ben precisi, a cominciare dalla consapevolezza di quanto sia importante la presentazione grafica:
• scrivere e impaginare con cura la relazione: frontespizio con i dati dello studente, un titolo, la data del colloquio; un carattere standard, come Times New Roman o Verdana; corpo 12, con interlinea almeno 1,5; margini adeguati per rendere la pagina ariosa;
• per l’eventuale supporto multimediale, curare la leggibilità oltre che l’efficacia del contenuto: caratteri grandi e nitidi (ideali i font “bastone” come Arial o Calibri), sfondi e colori adeguati alla lettura su schermo luminoso; poco testo, soprattutto parole chiave e frasi brevi; niente immagini o effetti speciali fini a sé stessi. Si possono utilmente impiegare anche i modelli standard disponibili in ogni programma di composizione;
• numerare le pagine della relazione e le slide dell’eventuale supporto multimediale;
• dopo un po’ di tempo che sono state ultimate, rileggere attentamente sia la relazione che le slide, meglio se su carta (a video gli errori sfuggono facilmente). L’ideale sarebbe poi far rileggere i testi a qualcun altro, il quale noterà più facilmente dell’autore eventuali sviste e aspetti da chiarire.
La struttura
Il requisito primario di una relazione è quello di essere economica e funzionale. Chi la legge deve essere facilitato nell’individuare i passaggi fondamentali e i punti che più lo interessano, quindi è necessario
• organizzare il testo in paragrafi, dotati preferibilmente di un titolo che ne indichi il contenuto;
• rendere i paragrafi il più possibile autonomi, in modo che possano essere letti anche non in sequenza;
• evitare o limitare i rimandi interni (per rendere indipendenti i diversi blocchi di testo);
• se è prevista una presentazione multimediale, far corrispondere a ciascun paragrafo, anche nel titolo, una slide;
• evidenziare nel testo parole chiave o passaggi particolarmente importanti attraverso accorgimenti grafici (neretto, sottolineatura, riquadro ecc.);
• non inserire immagini prive di funzionalità, per puro intento decorativo.
Il contenuto
La relazione deve comprendere i seguenti aspetti:
• rapida descrizione dei PCTO nel loro complesso, cioè parte formativa e attività svolte nel contesto di lavoro;
• rapporto tra l’esperienza di lavoro e il proprio indirizzo di studi;
• descrizione delle attività che lo studente ha svolto oppure osservato nel contesto di lavoro;
• considerazioni sui rapporti con le persone (i tutor scolastici ed esterni, i colleghi nel contesto di lavoro);
• competenze acquisite attraverso i PCTO e integrazione o meno di esse con quelle di carattere teorico già possedute;
• considerazioni e valutazioni circa il contenuto e le modalità dell’esperienza fatta. Non ci si deve esimere dal dare un giudizio negativo, quando è necessario: l’importante è presentarlo con civiltà, argomentarlo adeguatamente ed esporre le critiche in maniera costruttiva, facendo capire che l’obiettivo è segnalare un aspetto carente per migliorarlo e non semplicemente manifestare disappunto, fastidio, delusione;
• ruolo dei PCTO per l’orientamento delle proprie scelte future;
• eventuali proposte per migliorare le attività, sia quelle preparatorie che l’esperienza di lavoro, in modo da renderle più coerenti con il percorso di studi e più efficaci.
Il linguaggio
Nella relazione lo studente deve esprimersi in maniera diretta, chiara e concisa, evitando ambiguità e possibili equivoci, e mantenendo un tono professionale. Dovrà perciò
• attenersi al registro formale;
• limitare l’uso di aggettivi e avverbi, che non devono abbellire il testo ma aggiungere qualcosa sul piano dei contenuti;
• ricorrere a una sintassi lineare, con periodi brevi e prevalenza di coordinazione rispetto a subordinazione (la relazione potrebbe essere letta dalla commissione d’esame, nelle sedute preparatorie del colloquio, ad alta voce: deve quindi essere possibile seguirla facilmente anche senza avere il testo sott’occhio);
• non abusare del pronome “io”, ma trattandosi di un tema che investe la sfera del personale meglio comunque usare prevalentemente i verbi alla prima persona singolare. Il ricorso ad altre forme (impersonale, passivo) tende a creare una distanza tra l’interessato e l’esperienza: ma non è detto che, volendo prendere distanza da qualche passaggio, non torni utile anche questo.