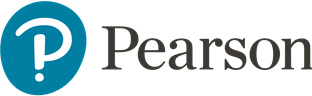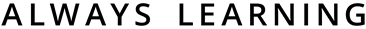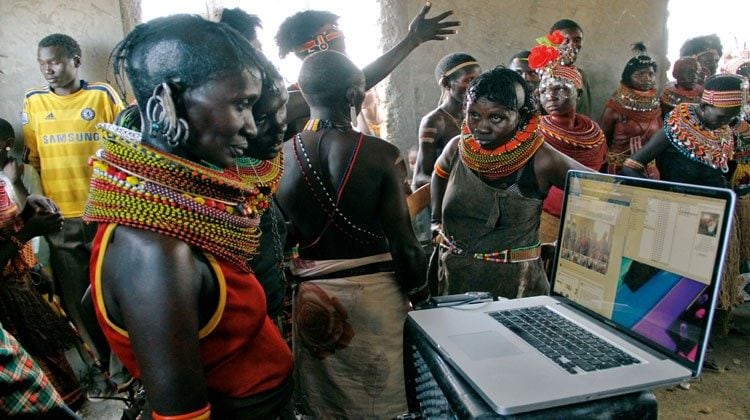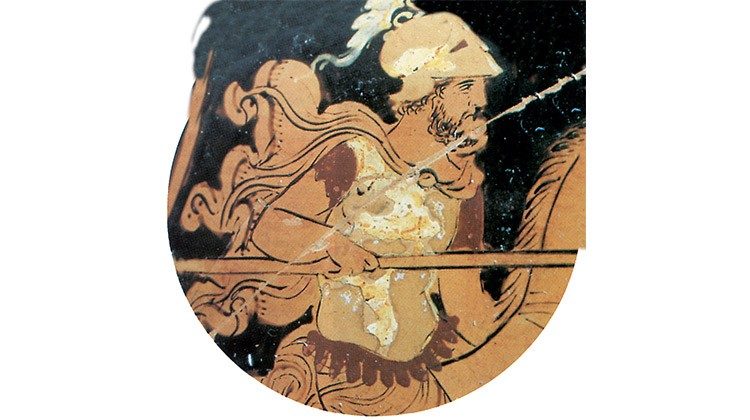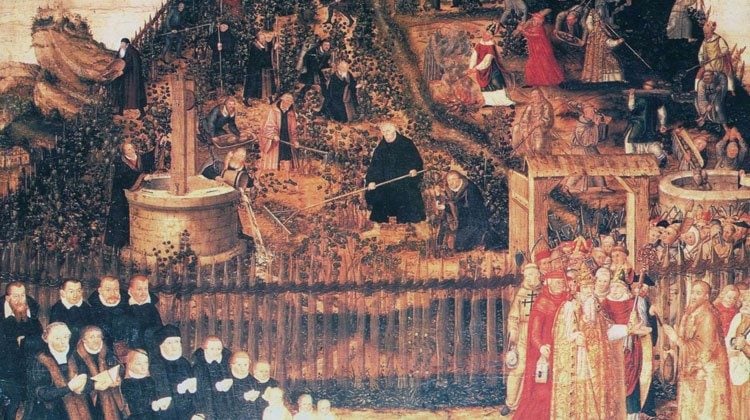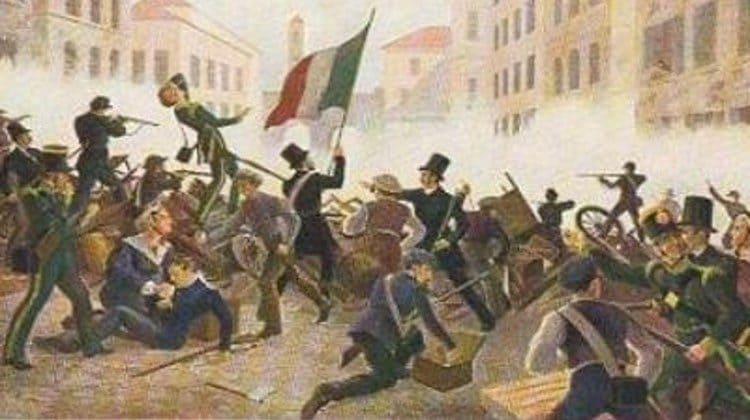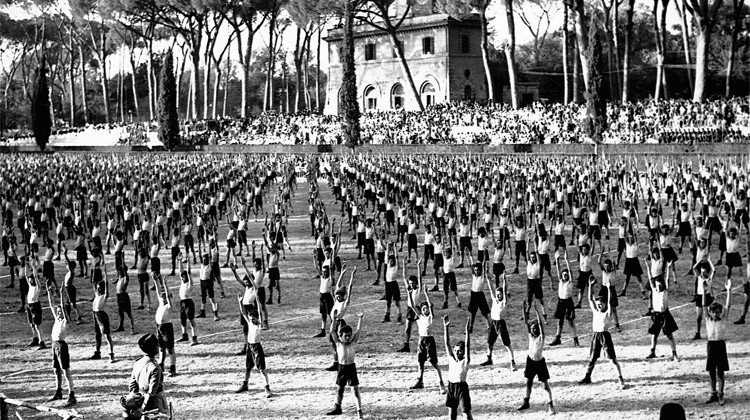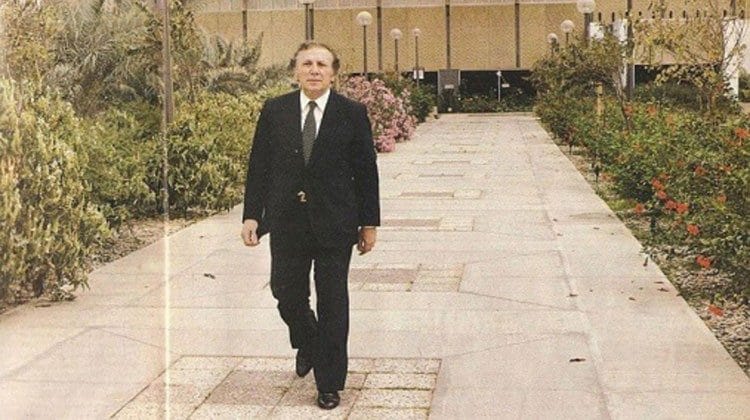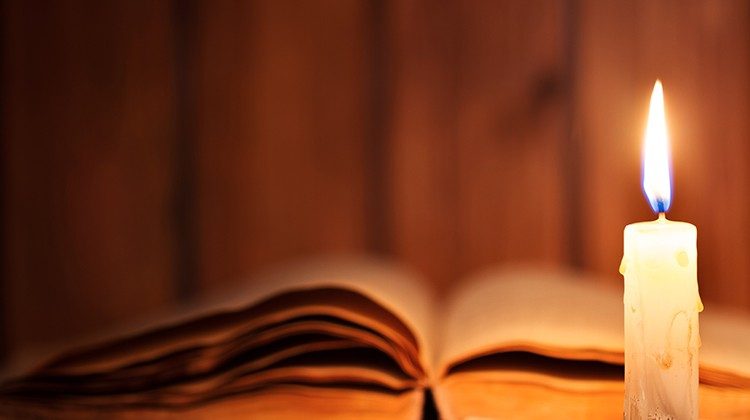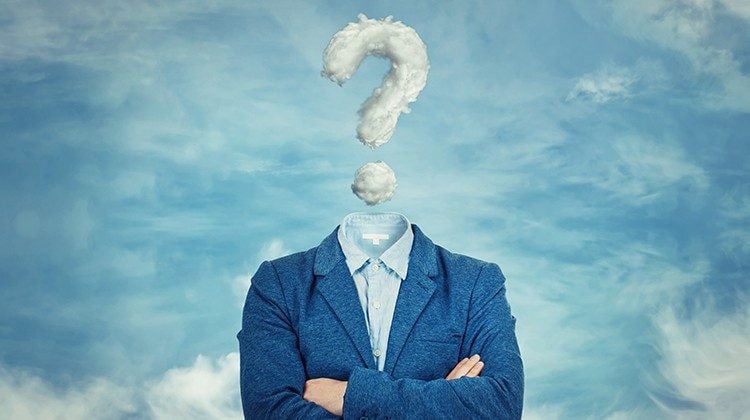Libri in classe. La Resistenza

LIBRI IN CLASSE
Considerate che avevo quindici anni. Il diario di prigionia di Magda Minciotti tra Resistenza e deportazione di Anna Paola Moretti
Sulla guerra civile. La Resistenza a due voci di Giulio Guidorizzi
Storie di GAP. Terrorismo urbano e Resistenza di Santo Peli
Partigia: una storia della Resistenza di Sergio Luzzatto
La Resistenza perfetta di Giovanni De Luna
Considerate che avevo quindici anni. Il diario di prigionia di Magda Minciotti tra Resistenza e deportazione
Autore: Anna Paola Moretti
Editore: collana di ricerche storiche dell’Istituto Storia Marche, 2017
Pagine: 314
Il libro di Anna Paola Moretti, parte della collana di ricerche storiche dell’Istituto Storia Marche, è contemporaneamente sia una toccante testimonianza umana, sia una valida fonte storica. Due sono gli interrogativi che alimentano e attraversano l’intera opera: comprendere le profonde motivazioni che hanno spinto una quindicenne a tenere un diario negli anni di prigionia e il bisogno che spinge, noi oggi, a leggerlo e meditarlo. Il diario intitolato Le mie prigioni, vera rarità nel suo genere, scritto in fretta con «mozziconi di matita» dal 23 luglio 1944 al 3 aprile del 1945 tra Ripe (Ancona) e Bayreuth (Baviera), racconta dell’arresto da parte delle SS, della reclusione, dell’internamento e del lavoro coatto di Magda Minciotti, strappata con violenza al mondo della sua adolescenza e catapultata nell’inferno del lager. Le bozze verranno poi trascritte e riviste dall’autrice dopo la liberazione, gelosamente conservate negli anni e infine affidate alla cura del figlio pochi mesi prima della morte, nel luglio del 1990. L’immediata sensazione che si prova nel leggere questa testimonianza è la vibrante richiesta di ascolto: le pagine desiderano e ricercano degli interlocutori. Esse nascono innanzitutto come conforto e sollievo alla solitudine e alla disperazione e obbediscono alla necessità di recuperare quella dignità di persona, negata dalla prigionia. Esprimono e comunicano un intenso bisogno di sentirsi ancora vivi. La scrittura diventa così una sottile filosofia individuale di sopravvivenza, una forma di resistenza e resilienza alla barbarie della disumanizzazione. Dal diario emerge una forza e un’umanità tutta al femminile, sempre attenta alla cura di sé e all’igiene personale, ad allacciare relazioni solidali, a creare amichevoli legami empatici, senza mai perdere i contatti con la famiglia e la madrepatria. Senza mai disperare, soprattutto, in quanto Magda è perfettamente consapevole che l’avvenire non deve mai privarsi di quel coraggio che ha sempre caratterizzato la sua vita passata.
Sulla guerra civile. La Resistenza a due voci
Autore: Giulio Guidorizzi
Editore: Bollati Boringhieri, 2015
Pagine: XXIII-177
Come gli eventi della Resistenza hanno condizionato la successiva storia della Repubblica? In che senso si può parlare di guerra civile? Su queste e diverse altre domande s’interroga il libro di Norberto Bobbio e Claudio Pavone. Tra i due autori, entrambi resistenti non armati, prevalgono sicuramente le convergenze interpretative e la volontà condivisa di non cadere nella trappola delle liturgie celebrative e ideologiche (“Resistenza tradita”), dei forzosi canoni storiografici (“un secondo Risorgimento”) e delle strumentalizzazioni politiche (“giustificazione della lotta armata”). La Resistenza, per i due autori che ne furono protagonisti e “superstiti”, fu innanzitutto una complessa e concreta esperienza di uomini e donne mossi da passioni e ideali, un moto popolare interclassista, capace di produrre una nuova classe dirigente e rinnovate istituzioni democratiche, in radicale discontinuità con il passato: un nuovo inizio e un fondamento nello spirito civile e nella prassi politica. Nella prima parte del libro sono raccolti quattro brevi saggi per ciascun autore (scritti tra il 1965 e il 1994), mentre nella seconda è proposto uno scambio epistolare inedito tra gli stessi. La Resistenza appare come un intreccio multiforme di più storie: movimento patriottico di liberazione contro il nemico interno (fascismo) ed esterno (nazismo), lotta sociale per l’emancipazione della classi lavoratrici, guerra fratricida tra italiani accanitamente contrapposti tra loro nel marasma della disgregazione di ogni quadro statale e istituzionale. Non mancano riflessioni sulla relazione tra l’agire armato e i principi e i valori etici, sulla differenziazione tra resistenza attiva e passiva, sui legami con i contesti europei e sulla necessità di continuare a indagarne criticamente le radici e l’eredità.
Storie di GAP. Terrorismo urbano e Resistenza
Autore: Santo Peli
Editore: Einaudi, 2014
Pagine: 279
Comprendere la Resistenza nella sua grandezza e nei suoi limiti, nelle sue complesse connessioni storiche e nel suo andamento non lineare e composito, senza cedere né a stereotipi né a semplificazioni: questo il proposito del libro di Santo Peli. Il libro ripercorre criticamente la nascita, il reclutamento, le strutture, la logistica, le strategie, le tecniche di combattimento e il ruolo politico dei GAP, Gruppi d’azione patriottica, voluti, attuati e diretti dal Partito comunista italiano, collocandoli nel contesto storico del convulso triennio 1943-45. Santo Peli, studioso di Storia contemporanea, rivede la consueta “geografia”, ben radicata nella memoria collettiva, che aveva nella montagna, “patria del ribelle”, il teatro privilegiato dello lotta, e riporta il fulcro dell’analisi nella città, centro e cervello degli orientamenti e delle decisioni politico-militari. Sono proprio le città il luogo dove la lotta di liberazione si trasforma, evolve e produce gli attentati terroristici dei GAP, finalizzati a evidenziare le fragilità del sistema repressivo nazifascista e incoraggiando, nelle intenzioni, la rivolta delle classi popolari. È qui che si forma e agisce “il guerrigliero di città”, il “rivoluzionario professionale” dei gruppi armati comunisti, indottrinato e addestrato nello scegliere i bersagli adeguati per creare “un’atmosfera di guerra”. La sua figura poliedrica, carica di travagli morali, disagi materiali, solitudini e aspettative, è ben analizzata dall’autore, nei suoi strettissimi legami con i progetti propagandistici nazional-patriottici del Partito comunista, tutto teso ad assumere un ruolo predominante nella Liberazione. Nascono così ricostruzioni di quelle vicende molto documentate e approfondite.
Partigia: una storia della Resistenza
Autore: Sergio Luzzatto
Editore: Mondadori, 2013
Pagine: 371
La volontà e la curiosità, quasi ossessiva, di misurarsi «da figlio, da padre, da cittadino e insegnante» con uno degli snodi decisivi della nostra storia, ha spinto Sergio Luzzatto, docente di Storia moderna all’Università di Torino, a scrivere questo libro. Partigia è l’appellativo con cui venivano chiamati, in piemontese, i combattenti più audaci e svelti di mano, e coincide con il titolo di una poesia del 1984 di Primo Levi, ispiratore e “comprimario”, di tutte le trame narrative del libro. Ispiratore, in quanto le poche pagine del racconto Oro, contenuto nel suo Sistema periodico (1975), diventano la fonte per approfondire una apparentemente marginale microstoria, piccola nello spazio e nel tempo, di una banda partigiana di Col de Joux (sulle montagne della Valle d’Aosta, nell’autunno-inverno 1943), che, rigo per rigo, si dilata in una storia della Resistenza sempre più ampia e complessa. È qui che la figura di Levi si trasforma da protagonista in comprimario, sfilandosi dal testo e facendo emergere in primo piano i temi fondamentali dell’opera che focalizzano e indagano i dilemmi delle tormentate scelte morali ed esistenziali di una generazione di giovani allo sbando, dopo il dissolvimento militare e socio-politico dell’Italia dell’8 settembre 1943. L’autore è molto attento a intessere e ricostruire le personali storie dei partigiani nei loro legami con il territorio e le popolazioni locali, la presenza degli ebrei italiani nelle bande, i processi del dopoguerra, gli intrecci, a prima vista paradossali, con gli uomini del governo collaborazionista («il partigiano ebreo salvato dal prefetto antisemita»). Ne esce un modo di raccontare e spiegare la Resistenza per niente agiografico e “dorato”, ma attento alle debolezze e ai drammi individuali e guidato dal bisogno di trasmetterne l’eredità spirituale, scevra da visioni oleografiche e impostazioni manichee. Storie, come evidenzia Luzzato, che hanno «la verità complicata delle sfumature». Perché, ricorda Levi, nel finale della poesia, per i partigia «non c’è congedo»; essi devono rimanere sempre vigili sentinelle di fronte ad ogni forma di male interiore ed esteriore che s’incarna nei sempre nuovi e attuali revisionismi e negazionismi.
La Resistenza perfetta
Autore: Giovanni De Luna
Editore: Feltrinelli “Storie”, 2015
Pagine: 254
La straordinaria e coinvolgente testimonianza di Leletta, una giovane aristocratica diciassettenne, con una solida e fervente fede religiosa, è l’originale sguardo attraverso il quale Giovanni De Luna fa rivivere La Resistenza perfetta. Luogo delle vicende è la grande villa patrizia “il Palas” dei conti Malingri a Villar (a Bagnolo Piemonte, tra Saluzzo e Pinerolo) che ospitò, nei venti mesi tra il 1943 e il 1945, insieme alla famiglia della ragazza, anche i partigiani comunisti delle Brigate Garibaldi, guidati dall’energico e determinato capo “Nicola Barbato” . È qui che le storie della giovane e del partigiano, la cattolica e il comunista, la monarchica e il repubblicano, s’incontrano e prendono forma, nel tragico contesto degli orrori della guerra civile. L’autore docente universitario di Storia contemporanea a Torino, sfuggendo a ogni impostazione retorica e conformista, vuole dar voce e sostanza all’autenticità dei valori umani, morali e civili che animarono quelle vicende, per nulla predeterminate da logiche politiche d’esclusione e contrasto. La Resistenza perfetta ha quindi come protagonista quel «mondo della vita», concreto e vero, quel «corpo unico» di uomini e donne non ancora separati e divisi da posteriori etichettature ideologiche o da strumentali riletture revisioniste. Ne esce il quadro di una Resistenza vista come un «universo problematico e contraddittorio», carico di sincero senso civico e gesti di solidarietà, incertezze e condivise speranze di libertà e tenuto assieme dal forte senso d’appartenenza a una comunità e da radicate regole non scritte. La bravura di De Luna è quella di dare dignità, spessore e profondità alla memoria storica di questi intrecci, mediante un meticoloso lavoro di ricerca d’archivio. L’autore riesce quindi a collocare gli eventi nel vivo della brutalità dell’occupazione nazista e del governo collaborazionista della RSI, senza perderne mai la freschezza e la spontaneità della vita in divenire.