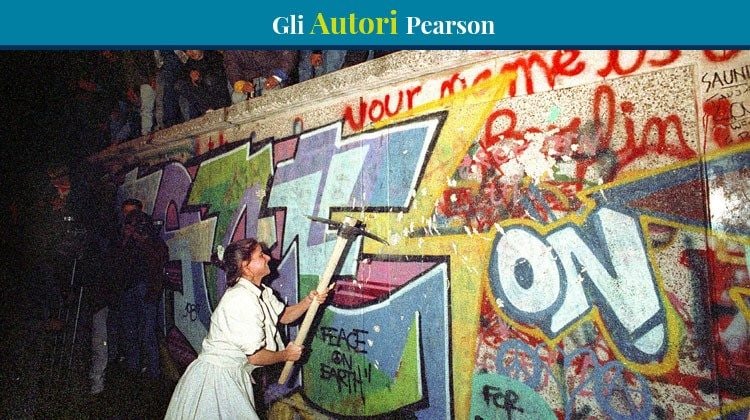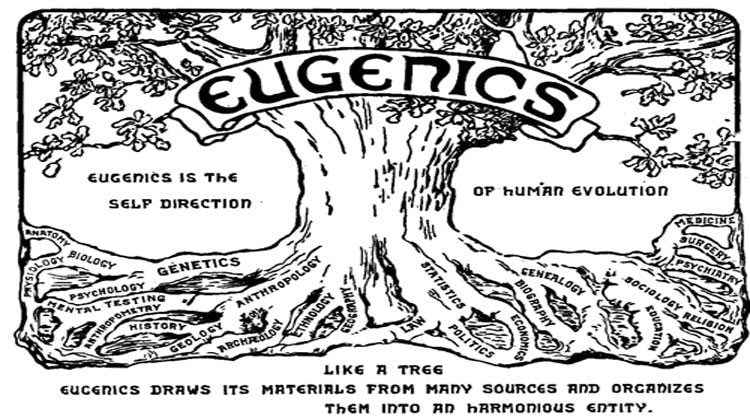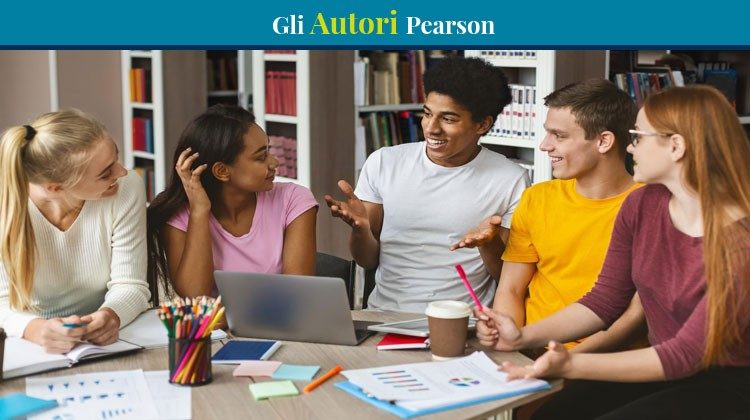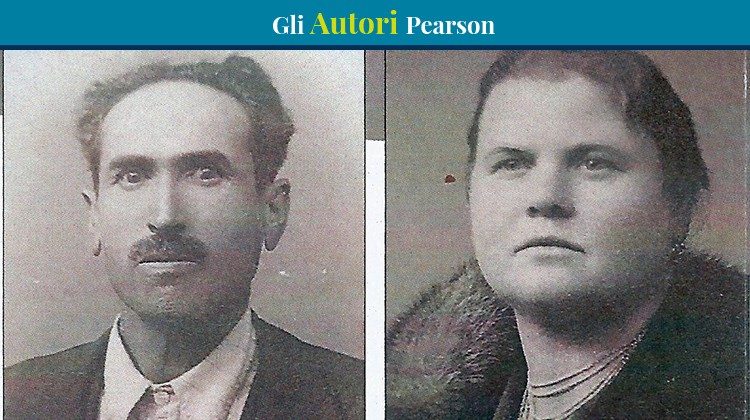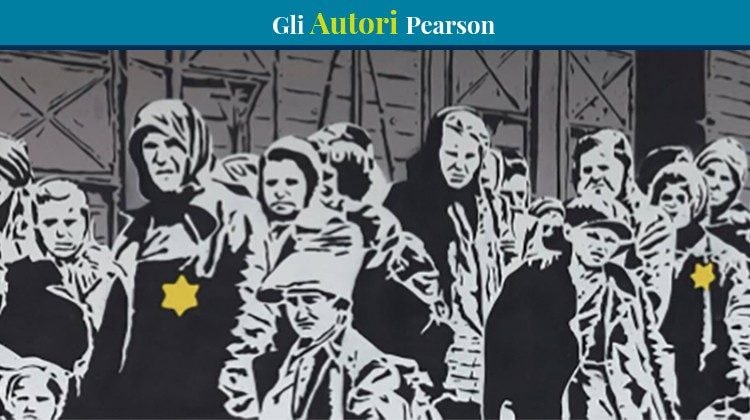Questione femminile e mondo del lavoro

EDUCAZIONE CIVICA E TEMI DI ATTUALITÀ
Un excursus approfondito e documentato sul percorso di emancipazione delle donne lavoratrici in Italia, dal Risorgimento agli anni settanta del Novecento: dall’accesso a tutte le professioni, alle prime tutele delle madri lavoratrici, alla legge contro il licenziamento per matrimonio.
La donna come “angelo del focolare”
Nel corso dell’Età moderna le donne restano generalmente confinate in casa e spesso la loro eventuale attività professionale viene esplicitamente considerata come «disonesta e infamante». Contestualmente va diffondendosi l’idea che sia il marito a dovere mantenere la moglie e la famiglia. Il contributo femminile viene pertanto considerato accessorio e, a partire dal XVIII secolo, l’ozio delle donne viene visto come un segno di rango presso gli emergenti ceti medi. Si consolida così l’idea della donna intesa come moglie e madre, interamente votata alla casa e all’educazione dei figli, un vero e proprio “angelo del focolare”.
Un angelo debole, inferiore all’uomo per struttura fisica e capacità mentali, da tutelare come un bambino.
Quest’immagine attraversa tutto il XIX secolo, che per l’Italia è anche l’epoca delle lotte per l’unificazione nazionale. Vi sono, è vero, donne impegnate in prima persona e in prima fila (come Cristina Trivulzio di Belgiojoso), ma in genere il compito di mogli e madri è quello di spingere mariti e figli a combattere per la patria. «O madri, alla pugna spingete la prole / fanciulle, voi stesse con forti parole / in pugno agli sposi ponete l’acciar», recita una poesia di quel periodo. Rimangono i tradizionali compiti di retrovia: raccogliere soldi per armare i volontari garibaldini, cucire camicie rosse e bende, o fungere da infermiere sui campi di battaglia.
La fine del Risorgimento porta a un peggioramento della condizione delle donne, perlomeno di quelle lombardo- venete e toscane. In base al codice civile austriaco (1811) e alla legislazione civile dei granduchi di Toscana, le donne potevano infatti amministrare liberamente i loro beni e, se possidenti, potevano votare nelle amministrazioni locali. Nel Regno d’Italia, invece, la donna avrà bisogno dell’autorizzazione maritale per gestire i propri beni e non potrà votare né nelle elezioni amministrative né in quelle politiche.
L’affermarsi degli ideali liberali non porta quindi a quell’emancipazione femminile implicita nella teoria (uno Stato basato sull’eguaglianza dei cittadini non poteva negare alle donne alcuni fondamentali diritti). La stessa istruzione, per le figlie della borghesia che se la potevano permettere, aveva lo scopo di plasmare delle buone mogli e madri, umili e obbedienti, capaci di educare bene i figli e gestire la casa. Nel 1875, nonostante le forti resistenze opposte dalla mentalità dell’epoca, viene consentito alle donne l’accesso all’università. Compaiono così le prime laureate, ma l’accesso al mondo del lavoro è tutt’altro che semplice (se si esclude l’insegnamento ai bambini e alle ragazze). Anna Kuliscioff, laureatasi in medicina a Napoli nel 1886, vede respinta la sua domanda di lavorare presso l’ospedale di Milano ed è costretta a esercitare la professione nel suo studio privato. Lidia Poët, prima laureata in legge (a Torino nel 1881), nel 1883 viene cancellata dall’albo degli avvocati.
Un percorso accidentato
Il cammino per l’accesso delle donne a tutte le professioni appare dunque nel nostro paese lungo e travagliato. Un primo passo è rappresentato dalla legge 17 luglio 1919, che, oltre ad abrogare l’autorizzazione maritale, ammetteva le donne a esercitare tutte le professioni e a coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi (e la lista è lunga) quelli che implicavano poteri pubblici giurisdizionali, l’esercizio di diritti e potestà politiche e quelli che riguardavano la difesa militare dello Stato. Ma si dovrà attendere l’articolo 51 della Costituzione e la successiva legislazione (9 febbraio 1963) per vedere le donne accedere a tutti gli uffici pubblici e professioni.
Forza lavoro “flessibile”
Se per lungo tempo le donne sono escluse dalla maggior parte delle professioni e dai ruoli direttivi, sono invece largamente sfruttate nel lavoro di fabbrica. Nel 1907 il 53,46% degli addetti all’industria è costituito da donne, che salgono al 78,51% nell’industria tessile. Spesso gli imprenditori le preferiscono agli operai maschi perché ricevono compensi inferiori e sono considerate meno propense allo sciopero. La prima legge che tutela il lavoro delle donne è quella approvata il 19 giugno 1902. La cosiddetta legge Carcano, oltre a disciplinare l’impiego dei minori (divieto di lavoro ai minori di 12 anni, divieto di lavori pericolosi e insalubri ai minori di 15), limitava a 12 ore l’orario massimo, vietava i lavori sotterranei per le donne di qualsiasi età e il lavoro notturno per le minorenni (vietato poi a tutte le donne con r.d. 10 novembre 1907, che le escludeva anche dai lavori pericolosi e insalubri); compariva anche il congedo di maternità, stabilito in quattro settimane dopo il parto. Oltre a equiparare donne e maschi minorenni, questa legge rivelava quel pregiudizio borghese e familistico ben radicato anche negli esponenti del partito socialista.
Le stesse proposte socialiste presentate in parlamento da Turati nel maggio 1901, pur prevedendo maggiori tutele rispetto alla legge poi approvata, presupponevano la debolezza della donna in quanto tale e riaffermavano l’accessorietà del lavoro extradomestico rispetto a quello casalingo. Si richiedeva per esempio che le donne avessero il sabato pomeriggio libero per potersi dedicare alle «esigenze di famiglia» e che, in quanto madri o future madri, fossero protette da quei lavori, come quelli sotterranei o notturni, che potevano «deteriorare la razza».
La legge, valida solo per il lavoro industriale (escluso quello agricolo, a domicilio o nelle aziende familiari), dimostra una scarsa capacità protettiva e facilita i licenziamenti delle donne nei momenti di crisi economica.
Il preminente ruolo familiare riconosciuto alla donna ne giustificava infatti in via preventiva la possibile espulsione dal mondo del lavoro. Cominciano così le fasi cicliche di ingresso ed espulsione della manodopera femminile in base alle necessità politiche e alle congiunture economiche del momento.
Lavoro sì, ma su chiamata
Se a partire dal 1907 si assiste a numerosi licenziamenti e a un calo netto dell’occupazione femminile, con lo scoppio della Prima guerra mondiale le donne rientrano in maniera massiccia sia nell’industria sia nell’agricoltura.
Di fronte alle necessità della patria, viene sospeso (1914) e poi abolito (1917) il divieto del lavoro notturno e le donne vengono impiegate anche nei settori prima considerati meno adatti al gentil sesso, come, per esempio, l’industria pesante.
Il rientro dei reduci dalla guerra e il problema della disoccupazione maschile portano a una nuova espulsione delle donne dal mercato del lavoro, codificata in epoca fascista con una serie di leggi discriminatorie (divieto di insegnare determinate materie nelle scuole, salario dimezzato rispetto a quello degli uomini, limitazione al 10% del personale femminile negli impieghi pubblici e privati ecc.) accompagnate da leggi protettive (come quelle sulla maternità). L’ideologia fascista, con la sua esaltazione del mito della forza, dell’aggressività e del bellicismo, ribadisce il ruolo subalterno della donna, al quale contribuisce la dottrina cattolica. Sulla scia di Leone XIII (le donne sono «fatte da natura per i lavori domestici», Rerum Novarum, 1891), Pio XI afferma che il lavoro è una «corruzione dell’indole muliebre e della dignità materna, perversione di tutta la famiglia» (Casti connubii, 1930). La legislazione fascista fa di tutto per mantenere le donne a casa, salvo poi richiamarle al lavoro al momento dello scoppio della guerra, per garantire il funzionamento dei servizi civili.
Con il ritorno degli uomini dal fronte si assiste ai consueti licenziamenti (anche se più contrastati rispetto al passato), ulteriore conferma di un lavoro femminile considerato accessorio e subordinato alla principale funzione familiare della donna.
Tutela della maternità e sue conseguenze
Si calcola che, già prima dell’entrata in vigore della legge Carcano, il 50% delle operaie avesse un’età inferiore ai ventinove anni. Matrimonio e maternità coincidevano spesso con l’abbandono del posto di lavoro o con il licenziamento.
La legge del 1902 prevedeva, solo per il lavoro industriale, il divieto di impiegare le puerpere prima di quattro settimane dal parto. Non era previsto un indennizzo per il periodo di congedo e solo nel 1910 viene istituita la Cassa di maternità, che aveva il compito di erogare un sussidio non ragguagliato al salario (la Cassa era finanziata con contributi a carico dei datori di lavoro e delle lavoratrici). Nonostante, su richiesta degli industriali, il governo conceda una serie di deroghe all’applicazione della legge, dopo la sua entrata in vigore, e soprattutto dopo l’istituzione delle Casse di maternità, gli imprenditori preferiscono assumere le nubili.
Il regime fascista, in linea con la sua politica di crescita demografica, adotta diversi provvedimenti a favore delle madri. Nel 1925 viene istituita l’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia (Onmi) e viene esteso anche alle impiegate il periodo di riposo dopo il parto.
La legge del 1929 prevede alcune misure per le lavoratrici madri: il congedo esteso all’ultimo mese di gravidanza, due riposi giornalieri per l’allattamento, l’obbligo di istituire delle camere di allattamento, il diritto al mantenimento del posto durante il congedo e per altri tre mesi in caso di malattie conseguenti al parto. Nel 1934 sono previste ulteriori garanzie: l’estensione del periodo di congedo (un mese prima e sei settimane dopo il parto), il divieto di licenziare la lavoratrice nel periodo di gestazione (e non solo durante il congedo), i riposi di allattamento calcolati come ore lavorative, l’istituzione dell’assicurazione obbligatoria di maternità per le lavoratrici dipendenti e per quelle a domicilio. Questa normativa scoraggia però i datori di lavoro ad assumere manodopera femminile, tanto che vengono preferiti gli uomini anche in settori, come quello tessile, solitamente riservati alle donne.
Di fatto poi, come in passato, la nascita di un figlio o lo stesso matrimonio portano automaticamente alla perdita del lavoro.
Un’uguaglianza teorica
Nel dopoguerra le donne ottengono il diritto di voto (1945) e il riconoscimento, perlomeno a livello teorico, della parità con gli uomini. La Costituzione afferma infatti il principio dell’uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge indipendentemente dal sesso (art. 3), l’uguaglianza dei coniugi all’interno della famiglia (artt. 29-30), la parità salariale e la protezione della maternità (art. 37), l’accesso dei cittadini di entrambi i sessi a tutte le carriere (art. 51).
L’applicazione di questi principi, però, è lenta e contrastata. Basti pensare che il socialista Pieraccini, primo sindaco di Firenze dopo la Liberazione, propone l’allontanamento delle spose dal lavoro fuori casa. I democristiani suggeriscono invece il salario familiare, che consisteva nel dare all’uomo un salario doppio, in modo da poter consentire alla donna di svolgere in pieno la sua funzione familiare (era quanto avevano già chiesto le operaie cattoliche nel loro Congresso internazionale del 1922). Nella stessa Carta della lavoratrice, approvata dal congresso della Cgil (Firenze, giugno 1947), si lamenta la mancata attuazione di quel salario familiare «che permetterà alla donna sposa e madre la tranquilla dedizione alla cura della famiglia».
In questo contesto matura la legge sulla tutela delle lavoratrici madri del 26 agosto 1950, discussa per due anni e frutto di un compromesso fra la proposta governativa e quella, più avanzata, del sindacato e delle sinistre (progetto Noce-Di Vittorio, che aveva visto la partecipazione di assemblee di donne e madri).
La legge si estendeva alle lavoratrici dipendenti private e pubbliche, con l’esclusione delle mezzadre e coltivatrici dirette, e prevedeva una tutela a parte per quelle a domicilio o addette ai servizi familiari. Tra le varie norme essa prescriveva: il riposo obbligatorio tre mesi prima del parto (per le addette all’industria, otto o sei settimane per gli altri casi) e due mesi dopo, il divieto di licenziamento fino al compimento del primo anno di età del bambino, la creazione di camere di allattamento o di asili nido aziendali, la corresponsione di un’indennità pari all’80% della retribuzione, indennità posta a carico dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro le malattie (Inam) o del datore di lavoro per le lavoratrici non assicurate (in genere le impiegate).
Con l’entrata in vigore di questa legge, la pratica già diffusa del licenziamento delle lavoratrici in caso di matrimonio diventa prassi abituale e addirittura codificata, mediante l’inserimento nei contratti di lavoro della cosiddetta clausola di nubilato.
La lotta contro i licenziamenti per causa di matrimonio
Molte donne, pur di ottenere un posto di lavoro, firmano contratti in cui accettano di essere licenziate o di dimettersi in caso di matrimonio.
Le donne cercano diverse scappatoie per aggirare la clausola di nubilato, come sposarsi di nascosto o fingere di non potere avere figli. Molte donne invece rinunciano alle nozze e scelgono la convivenza.
Nel corso degli anni Cinquanta questa situazione viene denunciata da consigli comunali, sindacati e associazioni femminili (l’Unione donne italiane in primis). Le lavoratrici scrivono direttamente alle parlamentari e mandano lettere ai giornali per far sentire la loro voce (il settimanale “Noi donne”, la “Stampa”, il “Messaggero”).
Il Ministero del Lavoro, più volte interpellato sull’argomento, con una circolare del 20 maggio 1955 dichiara illecita la clausola di nubilato, in quanto priva la donna del diritto di realizzare la propria libertà e capacità giuridica e costituisce un modo di eludere il divieto di licenziamento fissato dalla legge sulla maternità. Ma i licenziamenti per matrimonio continuano a susseguirsi e serve a poco il ricorso ai tribunali.
L’iniziativa di Angelina Merlin
Fin dal 1951 Angelina Merlin presenta al Senato una proposta di legge per vietare il licenziamento delle donne che si sposano. Nessun uomo – fa presente la senatrice – è mai stato licenziato per matrimonio; anzi, gli uomini sposati e con figli vengono preferiti nelle assunzioni. La pratica del licenziamento per causa di matrimonio viene dunque condannata dalla Commissione Lavoro del Senato, ma il disegno di legge decade in seguito allo scioglimento del Parlamento.
La legge viene riproposta dalla senatrice Merlin nel 1953. Ne segue una lunga discussione, non priva di punte polemiche. Il Ministro del Lavoro Ezio Vigorelli teme addirittura che la legge possa privilegiare la donna che si sposa, perché nel suo caso occorrerebbe una motivazione per licenziarla, a differenza di tutti gli altri lavoratori.
Dopo vari rinvii, la legge, come avvenuto in precedenza, non viene approvata e decade con la fine della legislatura.
L’approdo alla legge contro il licenziamento per matrimonio
Nel 1961 alcune deputate e senatrici facenti parte dell’Unione donne italiane (Angelina Merlin, Giuseppina Re, Marisa Cinciari Rodano, Nilde Iotti, Anna Matera, Luciana Viviani) pubblicano a Roma il Libro bianco sui licenziamenti per causa di matrimonio in Italia, che raccoglie numerose testimonianze e documenti. Il 25-26 febbraio dello stesso anno si tiene a Milano un convegno organizzato dal Comitato di associazioni femminili per la parità di retribuzione, sotto il patrocinio della Società umanitaria.
Il convegno mette in atto non solo la condanna dei licenziamenti per matrimonio, ma anche una serie di proposte concrete: una legge che preveda il divieto di questo tipo di licenziamenti, la completa mutualizzazione degli oneri di tutela della maternità individuati come una delle principali cause di licenziamento), un ampliamento dei servizi sociali e la prosecuzione dell’azione sindacale e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica.
Nel corso di un paio d’anni si arriva all’approvazione della legge 9 gennaio 1963 sul «Divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio e modifiche alla legge 26 agosto 1950, n. 860». Le legge sancisce la nullità delle clausole di nubilato e dei licenziamenti a causa di matrimonio.
La lavoratrice allontanata ingiustamente dal lavoro aveva diritto «alla retribuzione globale di fatto sino al giorno di riammissione al servizio»; se decideva di recedere dal contratto di lavoro, aveva diritto al trattamento previsto per le dimissioni per giusta causa, fermo restando la corresponsione della retribuzione fino alla data del recesso.
Veniva inoltre trasferito a carico degli enti mutualistici (e non più solo dell’Inam) l’onere di indennità per il periodo di congedo obbligatorio.
Un’uguaglianza ancora lontana
Negli anni successivi si assiste a un aumento delle garanzie per le lavoratrici madri (legge 30 dicembre 1971), all’istituzione di asili nido comunali (legge 6 dicembre 1971) e all’estensione ai padri del diritto di assentarsi dal lavoro per la cura dei figli (legge 9 dicembre 1977 e 8 marzo 2000). Ancora oggi in Italia persiste l’immagine tradizionale della donna dedita prevalentemente alla famiglia e ai compiti di cura e di assistenza (dei figli, dei genitori anziani), situazione che la costringe spesso ad abbandonare il lavoro per la mancanza di adeguate politiche a sostegno della famiglia.